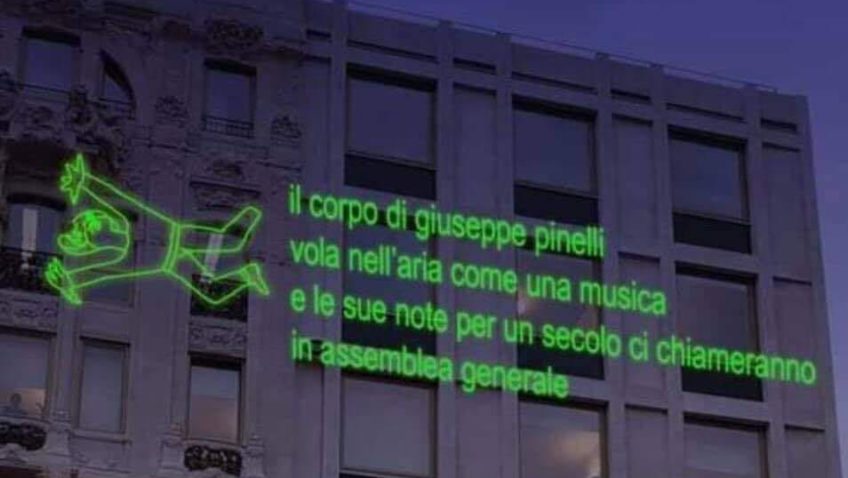Sulle tracce di un uomo senza volto e senza storia, protagonista della destra internazionale
Il 9 marzo scorso, in Francia, è morto un uomo che per tutta la vita ha cercato di non farsi trovare. Aveva 95 anni, era nato a Ploubezre, in Bretagna, e il suo nome era Yves Guillou. Nel ricovero per anziani di Le Revest-les-Eaux, il villaggio alle porte di Tolone dove ha trascorso gli ultimi cinque anni della sua esistenza, tutti lo ricordano come un signore sorridente e pacifico, la cui indole taciturna era certo da attribuirsi al morbo di Alzheimer di cui soffriva da tempo. Nessuno, a Le Revest-les-Eaux, poteva immaginare che quel vecchino dai modi gentili, con i capelli argentati e lo sguardo un po’ vacuo, avesse qualcosa di terribilmente inquietante da nascondere.
Portogallo
Era il 22 maggio 1974 quando un plotone di fucilieri di marina al comando del tenente Matos Moniz fece irruzione al civico 13 di Rua das Praças, nel centro di Lisbona. In Portogallo era scoppiata la rivoluzione dei Garofani, e il Movimento das Forças Armadas stava dando la caccia a tutti i collaboratori del vecchio regime neofascista. Al 13 di Rua das Praças – secondo alcune segnalazioni – aveva sede una finta agenzia stampa che agiva sotto copertura per contro della Pide, la polizia politica di Salazar, e dunque bisognava andare a darci un’occhiata. Il nome dell’organizzazione era «Aginter Press» e i suoi uffici consistevano in quattro stanzoni stracolmi di carte e schedari. Al tenente Matos Moniz bastarono pochi attimi per intuire che ad «Aginter Press» ci si occupava di tutto tranne che di giornalismo: c’erano macchinari per la fabbricazione di documenti falsi e microfilm, manuali di controguerriglia, lunghi schedari con nomi di militanti di estrema destra, appunti sulla guerra psicologica, sulla sovversione e sui colpi di Stato. Uno dei faldoni conteneva un breve foglio dattiloscritto, «La nostra azione politica». Il testo, in francese, recitava così: «Noi pensiamo che la prima parte della nostra azione politica debba essere quella di favorire l’installazione del caos in tutte le strutture del regime. Questo porterà a una situazione di forte tensione politica, di paura nel mondo industriale, di antipatia verso il governo e verso tutti i partiti. In questa prospettiva deve essere pronto un organismo efficace capace di riunire attorno a sé gli scontenti di ogni classe sociale: una vasta massa per fare la nostra rivoluzione». I militari portoghesi non potevano saperlo, ma il nome di quella strana agenzia era già comparso cinque anni prima in un appunto redatto dai servizi segreti italiani all’indomani della strage di piazza Fontana, il 17 dicembre 1969: «La mente organizzatrice [degli attentati] – vi si leggeva – sarebbe tale M. Guérin-Sérac, cittadino tedesco, il quale risiede a Lisbona ove dirige l’Agenzia Ager Interpress». Il vero nome di Guérin-Sérac – che aveva cittadinanza francese e non tedesca, essendo nato a Ploubezre, in Bretagna, nel 1926 – era Yves Guillou.
Banca dell’Agricoltura
Cosa fosse esattamente «Aginter Press» probabilmente non lo scopriremo mai. Grazie alle ricerche dei giudice Guido Salvini, che negli anni Novanta condusse l’ultima inchiesta sull’eccidio della Banca Nazionale dell’Agricoltura, sappiamo che la finta agenzia stampa di Rua das Praças fu fondata nel settembre 1966 da Yves Guillou e dal suo braccio destro Robert Leroy, un ex membro della Legione Wallonien delle Waffen SS. Guillou aveva all’epoca quarant’anni e si proclamava un paladino dell’anticomunismo più intransigente. Giovane ufficiale dell’undicesimo Régiment parachutiste de choc, aveva combattuto in Corea, Indocina e Algeria. Nel 1962 aveva aderito all’Oas, l’organizzazione terroristico-militare che si opponeva alla decolonizzazione del Nordafrica francese. Poi, dopo la vittoria del Fln, aveva trovato rifugio nel Portogallo di Salazar «per continuare la lotta ed estenderla alla sua vera dimensione, che è quella del pianeta», come avrebbe specificato in uno dei suoi rari interventi pubblici. I mezzi, ovviamente, non sarebbero stati quelli di Gandhi.
In Italia
A cominciare dalla metà degli anni Sessanta, Guillou e Leroy iniziarono a stringere legami operativi con i maggiori gruppi eversivi del neofascismo mondiale. In Italia i principali contatti furono con Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale, i cui militanti venivano invitati in Portogallo per addestrarsi all’uso delle armi e degli esplosivi. È certo che tra il 30 gennaio e l’1 febbraio del 1968 Yves Guillou ebbe un lungo incontro con Pino Rauti, mentre i rapporti con Stefano Delle Chiaie si sarebbero prolungati per buona parte degli anni Settanta. Così, nel giro di poco tempo, «Aginter Press» divenne la centrale operativa della cosiddetta «Internazionale nera», le cui spire si estendevano dall’Europa occidentale al Sudafrica dell’Apartheid.
Africa
Nel Terzo Mondo gli uomini di Aginter si misero al servizio dei movimenti anti-decolonizzazione, organizzando attentati e operazioni di controguerriglia in Algeria, Repubblica del Congo, Tanzania, Angola e Costarica. Sarebbero stati loro – secondo gli inquirenti italiani – ad assassinare nel 1969 il leader del Fronte di Liberazione del Mozambico Eduardo Mondlane, «reo» di essersi ribellato alle autorità portoghesi. Ma la vera specialità dei «lisbonesi» era soprattutto l’infiltrazione: sul finire degli anni Sessanta, dopo essersi spacciato per un reporter maoista, l’ex Waffen SS Robert Leroy riuscirà a intrufolarsi in diversi gruppi dell’estrema sinistra italiana, spingendoli su posizioni eversive e offrendo loro armi e tritolo. «A nostro avviso – si legge ancora nel documento La nostra azione politica -, la prima azione che dobbiamo lanciare è la distruzione delle strutture dello Stato sotto la copertura dell’azione dei comunisti e dei filocinesi. Ciò creerà un sentimento di antipatia verso coloro che minacciano la pace di ciascuno e della nazione». È lo schema-base di quella che sarà chiamata la strategia della tensione: organizzare attentati, farne cadere la responsabilità sui gruppi di sinistra e innescare così la reazione repressiva dello Stato. Di lì a poco ci sarà la strage fascista del 12 dicembre – e il capro espiatorio, non a caso, saranno gli anarchici.
Ha dichiarato alcuni anni fa l’ex terrorista nero Vincenzo Vinciguerra, già militante di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, e autore, nel 1972, dell’attentato di Peteano: «Gli agenti di Guillou parteciparono direttamente ai fatti italiani, compresa l’operazione di piazza Fontana». Vinciguerra e Guillou si sono conosciuti a Madrid nel 1974. Erano entrambi latitanti: il primo fuggiva da un mandato di cattura della magistratura italiana, il secondo aveva dovuto abbandonare precipitosamente Lisbona dopo il trionfo della rivoluzione dei Garofani. «Ideologicamente, Guillou era un fondamentalista cattolico – racconterà Vinciguerra -. Era un uomo molto pericoloso, molto affascinante e molto intelligente. Alle sue spalle c’erano senza dubbio i servizi segreti americani: l’obiettivo era sconfiggere i movimenti operai e stabilizzare l’Europa in senso anticomunista».
Volantini
Quale sia stato l’esatto ruolo di «Aginter Press» nella strage della Banca Nazionale dell’Agricoltura non è dato a sapersi. Di certo, oltre a quella celebre velina del 17 dicembre, c’è il fatto che vicino al luogo dell’eccidio furono rinvenuti alcuni finti volantini ornati di bandiere rosse, con la scritta: «Autunno 1969, l’inizio di una lotta prolungata». Spiegherà l’allora sostituto procuratore Ugo Paolillo, che fu il primo magistrato a indagare sulla strage: «Accertammo che la carta veniva dalla Svizzera e che i manifesti erano ricollegabili all’Oas». E poi: «Era una firma che riconduceva a Guérin-Sérac, il responsabile militare dell’Aginter Press. Proprio di Sérac mi parlò una persona, forse collegata ai servizi segreti, che chiese di vedermi a poche ore dalla strage. Non fidandomi registrai il colloquio. Purtroppo quel nastro è andato perduto».
Nella primavera del 1974, mentre gli uomini del comandante Matos Moniz facevano irruzione a Rua das Praças, i reduci di «Aginter Press» avevano già trovato rifugio nella Spagna franchista. Da lì, grazie anche al supporto di Vinciguerra e di altri «fuoriusciti» italiani, organizzarono numerose operazioni di «controguerriglia» in Portogallo e nelle isole Azzorre, nel vano tentativo di rovesciare il nuovo governo antifascista. L’impresa più clamorosa risale però all’estate del 1975, quando Guillou e i suoi luogotenenti idearono una serie di attentati dinamitardi contro le sedi delle ambasciate algerine di Roma, Bonn, Parigi e Londra. Le azioni furono tutte rivendicate da un’organizzazione inesistente, i «Soldats de l’Opposition Algérienne», ma la cosa che più spiccò all’occhio fu che per confezionare l’ordigno deposto in Germania erano state utilizzate nove cartucce di esplosivo militare C4, prodotto negli Stati Uniti e in dotazione alle forze Nato.
Cile
Fino agli anni Novanta l’unica immagine nota di Yves Guillou era una vecchia istantanea in bianco e nero, peraltro ripresa di spalle. Il «grande vecchio» della strategia della tensione era un uomo senza volto e senza storia. Nessuno sapeva che fine avesse fatto: dopo la morte di Francisco Franco, nel novembre del 1975, si era probabilmente trasferito nel Cile di Pinochet, ponendosi al servizio di nuovi assassini e nuovi macellai. Dopodiché, era letteralmente scomparso nel nulla. Tra il 1999 e il 2010, nell’ambito delle indagini sulla strage di piazza della Loggia, la procura di Brescia produrrà sul suo conto due distinte rogatorie indirizzate alle autorità francesi e spagnole. Per tutta risposta, oltre a una recente fotografia in formato tessera dell’ormai anziano ex militare, i magistrati lombardi riceveranno un lungo elenco di presunti indirizzi di residenza sparsi tra le isole Canarie, Madrid, Siviglia e la Costa Azzurra – tutti immancabilmente deserti. «Se ne conclude – chiosa l’ultima relazione del Fiscalía Provincial di Madrid – che Yves Guillou si trova in luogo sconosciuto».
Com’è possibile che le istituzioni di due paesi europei, dietro precisa richiesta della magistratura italiana, non siano state in grado di individuare un cittadino residente sul proprio territorio è un’altra questione che resterà probabilmente insoluta. Ciò che sappiamo con certezza è che il 12 marzo scorso, su un sito internet francese, è comparso il seguente annuncio: «Siamo addolorati di informarvi della morte di Monsieur Yves Guillou, avvenuta a Le Revest-les-Eaux all’età di 95 anni». È da qui che siamo partiti.
Per raggiungere Le Revest-les-Eaux bisogna inerpicarsi lungo una strada tortuosa fatta di infiniti tornanti. Il villaggio sorge arroccato sul cucuzzolo di una collina, ai piedi di un’antica torre saracena del XIII secolo. Gli abitanti sono poco più di tremila, per la maggior parte molto anziani e molto benestanti. È in questo angolo di paradiso che il fondatore di «Aginter Press» si è spento con serenità in un tiepido giorno di fine inverno. Non è stato difficile, presentandosi agli impiegati comunali come vecchi amici di famiglia, scoprire che Yves Guillou ha avuto come ultima residenza la locale maison de retraite, una piccola casa di riposo dalla facciata bianca e piena di vetrate. Era malato di Alzheimer – ci hanno detto – e perciò parlava molto poco. «Il povero signor Yves è arrivato qui nel 2017 – racconta in un inglese strascicato la direttrice dell’istituto -. Di rapporti con la famiglia non ne aveva ormai da anni. Però gli restavano molti amici, ed era gente che gli doveva essere parecchio affezionata. Venivano a trovarlo praticamente ogni giorno, nonostante il fatto che avere un dialogo con lui fosse quasi impossibile. Era un tipo proprio speciale, il nostro signor Yves».
Quanto il «signor Yves» fosse effettivamente «speciale» la direttrice della maison de retraite non può nemmeno figurarselo. I misteriosi amici che venivano a chiacchierarci con tanta assiduità in barba all’Alzheimer, invece, è probabile che ne sapessero qualcosa in più. Dopo qualche insistenza, sempre giocando la carta dei vecchi legami famigliari, siamo riusciti a ottenere il contatto di uno di loro. Lo chiameremo Monsieur B., ha circa 65 anni e fa l’imprenditore in una cittadina della Côte d’Azur. La storia che ci ha raccontato è la seguente: lui e Yves Guillou si sono conosciuti circa un decennio fa a Villefranche-sur-Mer, una tranquilla stazione balneare alle porte di Nizza. All’epoca l’ex ufficiale divideva un appartamento con la propria compagna e Monsieur B. era suo vicino di casa. Nel 2016 la fiancée di Guillou morì all’improvviso e i figli di lei, che evidentemente non lo avevano mai avuto in simpatia, sbatterono il vecchio militare in mezzo a una strada. Così Monsieur B. accompagnò il suo anziano vicino a Le Revest-les-Eaux e lo aiutò a sistemarsi nella piccola casa di riposo in cima alla collina. «Lo andava a trovare spesso?», gli abbiamo chiesto. «Certo, tutte le settimane». «E si è mai fatto raccontare la storia della sua vita?» «Oh no, di quello il signor Guillou non parlava proprio mai – si è affrettato a rispondere Monsieur B. -. So che è stato militare in Corea e Algeria, e credo che abbia anche avuto dei problemi legali con le autorità francesi. Ma di cosa abbia fatto in seguito, diciamo tra il 1960 e il 2010, non ne ho la benché minima idea. È probabile che a Villefranche-sur-Mer fosse conservato qualche documento a riguardo, ma quando hanno sgomberato l’appartamento i figli della signora hanno gettato tutto nell’immondizia. Sapete: è gente che fa uso di droga…».
Non farsi trovare, in un mondo interconnesso come quello in cui viviamo, è qualcosa di assai complicato. O forse basta avere gli amici giusti, specie se il tuo silenzio fa ormai più comodo agli altri che a te. Yves Guillou da Ploubezre, che ha trascorso una vita al servizio del potere, facendo assassinare innocenti e cercando di riportare indietro le lancette della storia, alla fine è riuscito nel suo intento. Oggi lo abbiamo trovato, ma quello che avrebbe potuto dire non lo dirà mai più.
* Fonte/autore: Andrea Sceresini, il manifesto
ph by Par Gilbert Dréan — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120080403