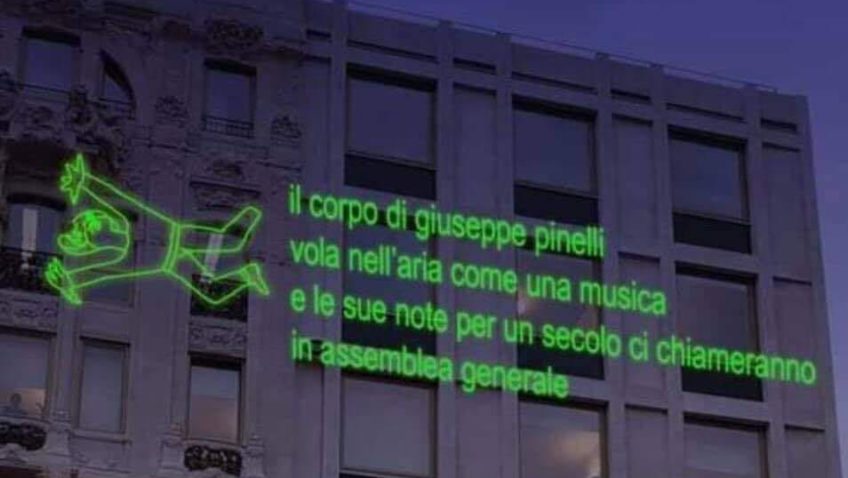Venezia 81. Nella sezione dei classici restaurati torna «Il terrorista», del 1963: la Resistenza dietro le quinte, con Gian Maria Volonté
Alla fine degli anni Cinquanta, nel quadro politico italiano si sta avviando il processo di riequilibri di potere e di alleanze che darà vita, dopo la caduta del governo Tambroni nel ‘62, alla coalizione governativa di centro-sinistra nel ‘63. Vi è nel Paese una forte ripresa della produzione industriale, un vero e proprio boom economico. Negli studi di Cinecittà il clima è però ancora da «guerra fredda»: i partigiani e la Resistenza sono per lo più sinonimi di comunismo ed evitando di mettere in scena il tema ci si sottrae anche da possibili noie censorie e politiche. Meglio raccontare altro. Tuttavia, alla XX Mostra del cinema di Venezia del 1959 vince il Leone d’oro, in ex-aequo con La grande guerra di Mario Monicelli, Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini dove più che il coraggio antifascista sembra prevalere l’improvvisato orgoglio emotivo.
Il successo del film di Rossellini è comunque un segnale per i produttori cinematografici, e a Cinecittà si riprendono immediatamente le fila del discorso resistenziale e della dittatura mussoliniana. Nel 1960, con le manifestazioni antifasciste di Genova e i dimostranti uccisi dalla polizia in varie città italiane, nei cinema si proiettano La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini, Era notte a Roma di Rossellini, Il carro armato dell’8 settembre di Gianni Puccini, La ciociara di Vittorio De Sica, Tutti a casa di Luigi Comencini, Il gobbo di Carlo Lizzani, ai quali seguiranno La ragazza di Bube di Luigi Comencini, La mano sul fucile di Luigi Turolla, Il processo di Verona di Lizzani, La marcia su Roma di Dino Risi, Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loy. Una «nuova ondata», quasi inaspettata ma forse figlia di un momento di profonda trasformazione della storia del Paese.
Il limite di questa seconda ondata è, tranne in alcuni casi, la connotazione da commedia, oscillando spesso tra la satira e la farsa, rinunciando, sempre con le dovute eccezioni, a un autentico approfondimento, a una rielaborazione critica e autocritica di quanto era accaduto. I conti con la dittatura vengono saldati male, senza puntare il dito sui colpevoli che magari continuano a spadroneggiare nel paese, evitando di mettere in luce le connivenze, la strategia degli interessi grandi e piccoli che avevano sorretto dapprima il fascismo, poi la Repubblica sociale italiana e infine il blocco conservatore democristiano. Più che ricordare e fare i conti con il passato, gli italiani vogliono dimenticare: sottolineiamo, che, tranne Il gobbo di Lizzani, dal discreto successo di pubblico, gli altri film incassano cifre piuttosto modeste, segno di un Paese anestetizzato dai crescenti consumi.
Alcuni dei film dei primi anni Sessanta tentano comunque un discorso diverso sulla Resistenza da quello affermatosi nella prima ondata che, per un brevissimo periodo, aveva assunto il ruolo di riferimento per la legittimazione reciproca delle forze politiche, una sorta di nuovo pactum associationis, e diventato ben presto un limite divisorio. Il paradigma antifascista, elemento comune di una possibile identità dopo il trauma del fascismo, aveva vissuto lo spazio di un fulgido mattino, forse solo quanto era bastato per scrivere la carta costituzionale e piangere tutti assieme commossi per la morte di Pina in Roma città aperta. Poi, era sceso velocemente il silenzio.
Uno dei film che nel 1963 cambia il paradigma cinematografico resistenziale è Il terrorista di Gianfranco de Bosio. Il regista veronese porta sullo schermo la figura di un gappista veneziano, apparentemente legato al Partito d’azione, ma solitario ed insofferente alle ragioni della politica, agli equilibri all’interno del Comitato di liberazione nazionale (Cln), alle conseguenze dei suoi gesti. È pervaso da un furore che si trasforma in azioni «terroristiche» contro i nazifascisti: un cane sciolto da quelle dinamiche politiche che già strutturavano la lotta partigiana e poi il dopoguerra repubblicano.
Il terrorista è uno dei pochi film, se non l’unico, che analizza e mette in scena in modo accurato ciò che stava «dietro le quinte» della Resistenza e cioè l’organizzazione politica e non solo militare della lotta antifascista. Ed è forse il primo, autentico, film resistenziale; di sicuro il più anomalo anche rispetto agli esordi cinematografici di quegli anni.
De Bosio conosceva bene, e non per sentito dire, la lotta partigiana nel Veneto e a Venezia. Studente all’università di Padova, dopo il proclama del rettore Concetto Marchesi, decide di aderire dapprima al Cln universitario e poi ai Gruppi di azione partigiana, piccole formazioni cittadine isolate in una clandestinità assoluta. Il Gap è comandato da Otello Pighin (nome di battaglia Renato), un ingegnere tra i primi organizzatori della Resistenza, che, caduto in un’imboscata l’otto gennaio del 1945, viene torturato e fucilato. Anche il giovane de Bosio è arrestato nel marzo del 1944, ma viene rilasciato (o, forse, riesce a scappare) e inviato da Igidio Meneghetti a Verona ad organizzare la lotta partigiana.
Il terrorista nasce per volere della «22 Dicembre», la società di produzione fondata, appunto, il 22 dicembre del 1960, da Tullio Kezich, Ermanno Olmi, Alberto Soffientini e Filippo Meda, i quali chiesero a de Bosio, fino ad allora regista teatrale, di proporre alla società un soggetto cinematografico per un film da produrre. De Bosio si mette subito al lavoro assieme a Luigi Squarzina per passare dal soggetto alla sceneggiatura. Nella sceneggiatura i ricordi del regista del periodo resistenziale entrano prepotentemente nel tono complessivo del racconto. Sono citati, seppure in modi e tempi diversi dai fatti reali, due importanti avvenimenti accaduti a Venezia tra il luglio del ’44 e la primavera del ’45. Il primo, con il quale si apre il film, è l’attentato a Ca’ Giustinian del 25 luglio del 1944 al quale partecipa, ed è ormai assodato, anche Franco «Kim» Arcalli, futuro montatore cinematografico e sceneggiatore di fama. Il secondo avvenimento, citato verso il finale del film, è la fucilazione, il 3 agosto del ’44, nell’allora riva dell’Impero, di sette detenuti politici come rappresaglia al presunto assassinio di un militare tedesco (probabilmente annegato casualmente).
Il tono che permea tutto il film è invernale, grigio, segnato da una profonda solitudine e dall’assenza. Venezia, la città minore e marginale che fa da set al film, è svuotata, piovigginosa, lontana. Vi domina un profondo senso di vuoto, come se i partigiani si muovessero in una zona morta, da soli, o, al massimo, in contatto solamente con altri partigiani. È la stessa dimensione de Il partigiano Johnny di Guido Chiesa, la stessa solitudine, dei due ex partigiani de I nostri anni di Daniele Gaglianone (non a caso, crediamo, due film girati nel 2000, un periodo in cui la Resistenza torna ad essere «memoria inquieta»): è come se il «corpo» della Resistenza si trovasse al di fuori della società quotidiana, dei suoi piccoli problemi d’ogni giorno in un isolamento oltre che fisico, psicologico, interiore, di chi sa che la sua scelta pericolosa e coraggiosa non può che portarlo fuori del corpo sociale, ma dentro la Storia.
Il terrorista è ambientato nel dicembre del ’43, siamo agli inizi della Resistenza armata, quando i Gap e i Cln si stanno dando una struttura. Nel film, vi è il conflitto che travolge il dibattito tra le componenti del Cln tra liceità o meno della violenza; vi è la dialettica tra le forze politiche antifasciste che già prelude a ciò che accadrà nel dopoguerra, ai suoi assetti; vi è l’impossibilità per alcuni individui, Braschi ad esempio, di entrare in questa logica. Interpretato da Gian Maria Volonté, Braschi è, per esplicita ammissione del regista, ispirato alla figura di Otello Pighin la cui filosofia era «un attentato al giorno per non dare riposo al nemico» e per ricordare costantemente ai nazifascisti che non erano benvoluti ma odiati. Braschi è fuori dalle logiche politiche, dalle alchimie dialettiche e ideologiche, ed è inoltre scettico nei confronti del futuro, nella possibilità di una libertà autentica. È un «terrorista», e non propriamente un eroe: si rifiuta costantemente di tener conto della necessità di collegarsi con gli altri partigiani, non ha alcuna cautela, non si preoccupa delle possibili rappresaglie.
Nel suo agire compie errori madornali per un resistente in clandestinità, come dimenticare l’indirizzo di Oscar a casa propria, o attuare azioni un po’ goliardiche, anche se giustificate, come far saltare in aria l’altoparlante che in campo Santa Maria Formosa trasmette i proclami nazifascisti, o peggio, sostituire all’ultimo minuto un compagno per l’azione dinamitarda alla sede de Il Gazzettino con risultati disastrosi. È proprio la costruzione antieroica accompagnata da un rigore morale autentico e da un’intransigenza senza possibilità di compromesso, che rende il personaggio interpretato da Volonté quello che ha più caratura drammatica e anti didascalica.
Quando Braschi spiega alla moglie, nel solo momento di tregua e di «normalità» del film, le ragioni delle sue difficili scelte, si capisce quale sia la funzione etica e politica che de Bosio vuole dare al personaggio: «Venti, trent’anni dopo che questo sarà finito… Perché ormai è chiaro, ci si fa… Chissà con che perdite ancora ma ci si fa… Se dopo ci sarà di nuovo un periodo che la gente si lascerà addormentare… Anestetizzare… Da un po’ di pace e di abbondanza… L’abbondanza e la pace fanno comodo a tutti… E magari per una questione di pane e minestra si sarà pronti a dare via tutto un’altra volta… La libertà un’altra volta… Allora… C’è solo la lotta. E siamo in pochi. Maledettamente pochi».
In più interviste, il regista ha ribadito che non era un dialogo impossibile nel ’43, e che gli interrogativi sul futuro, un certo scetticismo sulla possibilità di costruire una democrazia dalle basi solide, libertarie, circolava tra i partigiani. È probabile sia così, ma le parole chiaroveggenti di Braschi sono verosimilmente quelle di quanti, nel Sessanta, vedevano lo spirito della Resistenza affievolirsi e le speranze tramontare, e percepivano che di fronte al nascente benessere economico, «il piatto di minestra», gli italiani accettavano senza tanti problemi la lunga stagione conservatrice democristiana.
Il terrorista, ma anche a suo modo Chi lavora è perduto di Tinto Brass, sono film che, seppure con toni differenti e motivazioni drammaturgiche incomparabili, fanno affiorare il malessere nei confronti della situazione politica del paese, con il Pci alla finestra, il Psi che si prepara ad accodarsi alla stagione riformistica della Dc, e la breve, quanto intensa, stagione ciellenistica chiusa in un battibaleno e coronata solo da una costituzione che appare a molti solo una carta dei sogni. Quei film richiedono anche, implicitamente, che il dibattito storiografico sul fascismo e sulla resistenza riprenda su basi nuove, per poter essere liberati dal peso «politico» ed estetico del neorealismo (Brass, in particolare), dalla necessità pedagogica, dalla sacralizzazione del passato e del presente.
Gli anni attorno al 1960 chiudono sì idealmente lo sforzo collettivo della ricostruzione del dopoguerra e dell’elaborazione dei lutti – «la nottata è passata», direbbe Eduardo – ma il mattino si presenta irrisolto e pieno di contraddizioni. È il passaggio critico della società italiana che questi autori registrano ognuno a modo proprio e con sfaccettature diverse; ed è anche il passaggio critico del nostro cinema che espelle dal proprio corpo i residui più o meno tossici del fascismo, introiettando neorealismo e commedia rosa per passare ad altro.
Tra i critici che ne scrivono dopo la proiezione alla Mostra di Venezia nel 1963, Giovanni Grazzini ne condanna «l’impianto didascalico» («Squarzina e de Bosio hanno letto troppo Brecht per riuscire a liberarsi interamente dei suoi cascami pedagogici»); Leo Pestelli «l’eccesso di schematismo» («l’artiglio teatrale di Squarzina?», si chiede); Pietro Bianchi critica «la rottura tra la parte dialogata, lunga, minuziosa, didascalica, e la parte visiva, liricamente e drammaticamente più forte». L’affondo più duro proviene da «Cinema Nuovo», la rivista diretta da Guido Aristarco, che definisce la struttura del film «povera e gracile, e procede per quadri scopertamente illustrativi, dando adito a confusioni e contraddizioni, senza cioè che si riesca a contrapporre al rifiuto epico una nuova moralità, un’effettiva didascalicità». L’unico che lo apprezza è Lino Miccichè nelle pagine dell’Avanti!: «il film di de Bosio è tra le opere più serie sulla Resistenza che il cinema italiano abbia dato (…) e tra i più felici esordi registici degli ultimi tempi».
Non si può dire che Il terrorista abbia avuto buona stampa in Italia pur avendo, paradossalmente, vinto alla 24a Mostra del cinema di Venezia il Premio della critica italiana assegnato dal Sindacato nazionale giornalistici cinematografici e risultato il primo classificato nella Sezione opere prime della Mostra del cinema nel referendum della critica indetto dall’Avanti!.
In Francia venne accolto con grande attenzione: «fu amato da Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir che lo presentarono a Parigi – racconta de Bosio – e andò molto bene anche in altri Paesi di lingua francese». Freddy Buache, nei prestigiosi Cahiers du cinéma, sostiene nel 1965 che il film mostra «la catena della violenza (terrore e contro-terrore) senza aprire un dibattito morale sull’argomento. Rifiuta l’astrazione e propone un’analisi dialettica della situazione».
Anche l’esito commerciale è piuttosto modesto: incassa poco più di quaranta milioni di lire, pochissimo se si pensa che qualsiasi film di serie zeta raggiunge con facilità più di cento milioni al botteghino nel 1963. A sessant’anni dalla sua uscita in sala, torna però ora nella versione restaurata in 4K da Patricia Barsanti.
Non è fuori tempo: il momento sembra ancora una volta quello giusto.
* Fonte/autore: Giuseppe Ghigi, il manifesto