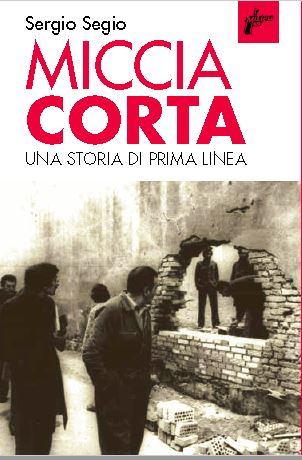Scrivere un saggio storico sull’esperienza di Prima Linea (Pl) è al tempo stesso un lavoro arduo e necessario. Arduo, perché Pl ha avuto un’origine complessa, che non si è immediatamente condensata in una linea univoca e monolitica: più che un filo, la sua storia appare come una fune composta da molti capi aggrovigliati, dalla quale pendono altre corde slegate. A ciò si aggiunga l’assenza di ricostruzioni storiche attendibili, combinata a una evidente ritrosia a narrare la propria storia da parte dei suoi attori (con poche eccezioni: Sergio Segio e, più di recente, Susanna Ronconi e Marina Premoli). Colmare questa lacuna nella storia dei movimenti rivoluzionari post-68 in Italia non è solo questione di completezza storiografica: si tratta di riconoscere che ogni rappresentazione storica è sempre parziale, sempre mediata dai documenti disponibili e dalla selezione che su di essi si opera.
Non è casuale che, nell’immaginario che si è affermato, di Prima linea si siano data una serie di rappresentazioni in buona parte distorte: un’organizzazione minoritaria rispetto alle Brigate rosse, “predisposta” al pentimento in ragione delle soggettività che la componevano (laddove nessuno dei suoi fondatori si è pentito), priva di una salda linea politica e di una conseguente elaborazione teorica – a dispetto della constatazione che una salda ortodossia ha per contro prodotto l’aberrazione dei boia nelle carceri e il divenire Caino della parte maggioritaria dei brigatisti detenuti1. Anche il paragone, a volte evocato da alcuni militanti, con Il Mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, contribuisce a dare un colore picaresco alla storia di Pl, ma rischia di confermare quel tacito accordo nella storiografia dominante sui cosiddetti “anni di piombo” che riconduce l’intera eversione armata alle sole BR. Una ricostruzione che fa apparire la sovversione armata come un fenomeno unico, una sorta di UFO, con reciproca soddisfazione di chi vuole negarne la natura diffusa e il radicamento sociale, e di chi vuole ricostruirsi una legittimazione storica a posteriori.
Basterebbe questo a rendere meritevole la ricerca di Andrea Tanturli, una tesi di dottorato dalla quale è tratto questo primo volume di Prima linea. L’altra lotta armata (1974-1981), che va dalle origini alla fine del 1979. Ci sono però anche specifici aspetti del lavoro storiografico che meritano di essere messi in luce. Come ogni vero storico, Tanturli si è chiesto quali documenti e quadri interpretativi accettare o rifiutare: la sua scelta costituisce una piccola lezione di metodo. Tanturli ha in prima battuta tenuto a distanza le ricostruzioni “continuistiche” – dai Quaderni Rossi agli omicidi BR senza fermate intermedie – inaugurate da Angelo Ventura, i complottismi alla Flamigni, e certe avventate ricostruzioni di Gotor. Al tempo stesso, Tanturli mette in guardia dallʼ«affidarsi alla sola stampa quotidiana per ricostruire la cronaca degli episodi» (p. 340), essendo i giornali «costellati da errori e imprecisioni», e comunque «una fonte estremamente piatta, poco incline allʼapprofondimento e di difficile verifica» (p. 19).
Più complesso lʼuso degli atti processuali e delle memorie: se lʼautore sceglie di «prestare fede, con le necessarie cautele, alle dichiarazioni dei militanti, anche di quelli pentiti, convinto che alcuni di essi abbiano restituito un quadro tutto sommato fedele della vita dellʼorganizzazione» (p. 19), è altresì vero che nel vagliare le singole dichiarazioni emerge un evidente sospetto verso una particolare tipologia di pentitismo che, invece di ricostruire o interpretare, «si nutre di condizionali, tende a venire incontro alle domande degli inquirenti»2. Siamo qui sul crinale che separa due diverse realtà, quella inquisitoria e giudiziaria, e quella politica e morale. Se infatti «le parole “pentiti” e “dissociati” si imposero allora a definire categorie diverse e misure di legge che senza accorgersene ripresero dal fondo più buio del passato italiano categorie di origine religiosa come il pentimento»,3 la dissociazione è stata espressione di un tentativo di fare i conti con la propria storia e i propri errori, nel quadro di una sconfitta delle ipotesi armate di cui solo una parte dei militanti hanno voluto prendere atto. Con le parole di Susanna Ronconi: «la dissociazione ha aperto uno spazio, nei modi che la situazione ha reso possibili, e anche chi allʼepoca non lʼha condivisa oggi dovrebbe, col senno di poi, capirlo. Siamo stati i primi a ricostruire la nostra storia collocandola nella storia di questo paese, dicendo che se non abbiamo avuto ragione avevamo delle ragioni, e chi dice che abbiamo “svenduto” una storia mente sapendo di farlo».4
Esplorata la cassetta degli attrezzi dello storico, veniamo allʼoggetto della sua costruzione. Su Prima line Tanturli è chiaro: «gli appartenenti a Pl prima di essere militanti clandestini furano militanti autonomi». Ma Pl non era «sic et simpliciter una sigla di copertura per il cervello centrale di una presunta Autonomia organizzata; è necessario quindi uscire dallo schema dellʼinnocenza o della colpevolezza, categorie non storiografiche, più adatte a giudici che si fanno storici e storici col complesso dei giudici» (p. 8). Il che significa riconoscere la natura plurale, variegata, desiderante e schizometropolitana, per dirla col linguaggio dellʼepoca, dellʼautonomia: «Ci furono aree dellʼautonomia, che, pur non rifiutando la violenza politica, furono relativamente immuni da sviluppi organizzati nel senso della lotta armata, altre che ci rimasero invischiate più o meno volontariamente, altre ancora che evolveranno, non senza lacerazioni, in formazioni clandestine» (p. 8). E dunque riconoscere quel carattere molteplice, moltitudinario dellʼarea della sovversione sociale e politica che non può essere ridotta ad unità. Dunque un libro come questo non può essere la parola che tutto squadri su Pl, ma un contributo, con gli strumenti propri della ricerca storica, che dovrebbe – è un auspicio, oltre che unʼesigenza – favorire una proliferazione di narrazioni, forse meno scientifiche e più soggettive, in grado di dar ragione «dellʼircocervo che per una volta soltanto si è unito per le teste in piazza Solferino: è morto per insufficienza funzionale del suo organismo mostruoso, come certe povere creature nate nei laboratori, troppo o troppo poco dotate per vivere, respirare, nutrirsi, come fanno quotidianamente organismi meno ambiziosi»5.
Un poʼ come Tristam Shandy, Prima linea impiega molto a nascere, pur parlando da lungo tempo. Non si tratta di un processo lineare e teleologico che da Lotta continua e Potere Operaio, attraverso Senza tregua, conduce a Pl, ma di una serie di attraversamenti, nel corso dei quali ciascun passaggio comporta acquisti e perdite, che forse avrebbero meritato un maggiore approfondimento (penso soprattutto alla figura di Mario Dalmaviva). E, vale ricordarlo, dove ogni passaggio non è dettato da unʼastrazione teorica, ma dallʼinterpretazione soggettiva del concreto darsi delle lotte e degli antagonismi.6 Il che rende difficile proporre una ricostruzione che distingua «una prima e una seconda Pl, a cui distribuire etichette di spontaneismo e di efferatezza» [p. 8]: ovvero, il mito dellʼorigine cui segue inevitabilmente una rovinosa caduta. Di fatto, è la stessa categoria di “origine” che va sottoposta a dura critica: come se la cacciata dal Giardino dellʼEden fosse il frutto di un tradimento dellʼoriginaria purezza, ovvero fosse già inscritta nellʼatto di nascita. Cattiva mitologia, in ambedue i casi. È invece vero che ogni processo manifesta una molteplicità di possibili, e che ogni decisione comporta la loro riduzione, ma anche il sorgere di nuove possibilità. Ma i processi e gli eventi non accadono in vitro, bensì allʼinterno di contesti popolati e imprevedibili, dalla cui interazione lo slancio del possibile può essere rilanciato oppure irrigidirsi fino allʼarresto. Detta così, una questione che risuona nel protagonista di Piove allʼinsù – «Certo, piacerebbe anche a me rintracciare un punto preciso lungo quei giorni, e vedere dove si è decisa la guerra dei vivi e dei morti» – è destinata a rimanere inevasa per assenza, e al tempo stesso per eccesso di risposte: piazza Fontana? Feltrinelli? Calabresi? Varalli? Più sensatamente, vale la pena di seguire il corso degli eventi, per verificare in quali momenti la molteplicità dei possibili è stata recisa dalla Grande Falciatrice della storia, sino a rendere irreversibile il percorso. Ad esempio, quando è stato oltrepassato il limite della vita umana, facendo dellʼomicidio politico un atto ordinario, se non inevitabile: e qui, più di ogni altra considerazione, vale la progressiva militarizzazione dei linguaggi, lʼassunzione della lingua di quello Stato che allʼinsubordinazione aveva dichiarato una guerra senza scrupoli e senza quartiere. Pl non nasce con lʼidea di calare sul proletariato la linea di partito cui le masse, incapaci di iniziativa autonoma, avrebbero dovuto docilmente assoggettarsi (per replicare un viaggio in treno già visto che dalla festosa partenza in Ottobre avrebbe avuto per destinazione lʼinverno siberiano). Neanche si riconosce nelle teorizzazioni dellʼoperaio sociale, un «neo-movimentismo» nel quale, come in un effetto-notte, lʼoperaio di fabbrica e il giovane operaio mobile del lavoro marginale, il disoccupato e lo studente proletario sono tutti bigi.
Volendo fissare due direttrici, potremmo tracciarle a partire dalla necessità di una «ricomposizione politica della classe guidata dai settori organizzati (e armati) della classe, un progetto di egemonia della fabbrica sui nuovi strati emergenti di proletariato»; e la proposta di una struttura che si metta al servizio del movimento, articolata su più livelli – lʼorganizzazione vera e propria, le squadre, le ronde – per attraversare quella «porta stretta» che è la «guerra civile di lunga durata». Al tempo stesso, viene esaltato «lʼantagonismo totale tra il sistema dei bisogni del proletariato» e la «necessità del capitale di imporre le proprie regole a tutta lʼorganizzazione sociale». Se lʼoffensiva va orientata contro «la proliferazione incredibile di figure di comando», per Tanturli «risulta spontaneo pensare a una sorta di “microfisica del potere”, ulteriore elemento che pone Pl in una seppur precaria comunicazione con il retroterra culturale alla base della riflessione sulla modernità» (p. 133). Nelle enunciazioni di Pl risuonano, non importa quanto consapevoli (come del resto in larga parte dellʼautonomia) le pagine del Foucault di Sorvegliare e punire e della Microfisica del potere. Ma se le ricerche di Foucault si radicavano nelle prassi delle nuove lotte trasversali, mancava alle pratiche e alle teorizzazioni del tempo una piena comprensione della complessa relazione fra assoggettamento e soggettivazione. Resta che «lʼindicazione di terreni conflittuali come quello della sanità, della psichiatria, della nocività ambientale sottintende un discorso sulla qualità della vita velleitario nella sua applicazione, ma in grado di cogliere le contraddizioni del mondo contemporaneo e del suo modello di sviluppo» (p. 337).
È altresì vero che lʼintera ipotesi che sorregge la galassia di Pl e delle squadre si basa su presupposti che la dura realtà dei fatti si incaricherà di smentire. In primo luogo, lʼaver sottovalutato la profondità dei processi di ristrutturazione in atto, che ridefiniscono in modo radicale la stessa soggettività operaia. Lʼautomazione, lʼallungamento delle linee di produzione sul territorio, lʼesternalizzazione erano processi già in corso, contro i quali le irruzioni nei luoghi del lavoro nero, o la violenza contro le singole figure del “comando dʼimpresa” si rivelano impotenti. Il capitale dava lʼavvio ai processi di globalizzazione, in risposta al potente ciclo di lotte che innerva il ʼ68 e gli anni successivi in buona parte dellʼOccidente: contro i quali mancava la capacità di immaginare una prassi allʼaltezza dellʼoffensiva.
Il rifluire dellʼoperaio sociale, che rimaneva ripiegato su se stesso – anche per lʼincapacità delle diverse realtà di movimento di dispiegarlo – determinò il progressivo restringimento di quellʼarea della sovversione dalla quale la “guerra civile di lunga durata” avrebbe dovuto trarre linfa. A ben guardare, dentro Pl la mancata affermazione di un’interpretazione chiara del rapporto fra organizzazione e squadre, e la mancata fusione con altre formazioni combattenti, hanno la loro radice nellʼesaurimento della spinta proveniente dalle lotte. Ormai in procinto di sfilacciarsi, Pl «consumerà le residue energie tornando nellʼambiente da cui tutto era cominciato, la fabbrica, ormai pressoché rasa al suolo nella sua architettura conflittuale» (p. 357). Ma «arroccarsi» nellʼassunzione di una sorta «di delega, di supplenza a quella che avrebbe dovuto essere la forza di un movimento sociale» (Susanna Ronconi, p. 356) è, di fatto, lʼammissione di una sconfitta.
La diffusione dellʼeroina, con esiti ben più devastanti delle bombe nelle banche e nelle piazze e sui treni – che lʼautore sottolinea più volte, inquadrando le azioni delle squadre contro gli spacciatori allʼinterno del «sorgere di nuovi terreni e nuove forme di antagonismo» (p. 200) – è, al pari della ristrutturazione della produzione, qualcosa che non poteva essere contrastata con la sola forza delle armi (e che attraverserà la stessa Pl). E attesta il cinismo dello Stato nello scatenare una guerra contro unʼintera generazione per prosciugare il mare della sovversione.
Del quale cinismo, vale la pena citare due documenti. La relazione del 1979 di Dalla Chiesa sullʼattività del proprio nucleo speciale, dove si richiede con crude parole lʼimperativo allontanamento «almeno dallʼesercizio dellʼazione penale» di «quegli elementi notoriamente indicati quali extraparlamentari»: gli «acculturati» e i «portatori – in veste di legalitari o garantisti – di “benevolenze” o “compromissioni”» (pp. 178-79). E una lettera di Dino Sanlorenzo, uno degli ideatori del famigerato questionario anonimo del Pci torinese sul terrorismo, sulla presenza di Segio e Ronconi in una cooperativa sociale nel 1988: «Il Comune gli dia pure delle commesse, […] per esempio lucidare e tenere in ordine le tombe di quelli che hanno accoppato, portare i fiori a quelli assassinati da Prima linea. Potrebbero dedicarsi agli handicappati o a spalare neve quando cʼè» (p. 326): dove lʼequiparazione degli «handicappati» a lavori cimiteriali, o comunque di scarto, dice tutto. Va però sottolineata, accanto alla sopravvalutazione della volontà dellʼoperaio sociale di scendere sul terreno della guerra civile, la sottovalutazione della forza militare e sociale del potere contro il quale le diverse opzioni di lotta armata si sono infrante: un errore politico ancor più grave in una formazione che aveva intuito più di qualcosa sulla struttura molecolare e reticolare del potere.
Ma se la rivoluzione era finita, se la fabbrica, alla vigilia della gigantesca rappresaglia dapprima dei 61 licenziati politici, e poi dei 14.500 espulsi (che erano anchʼessi licenziamenti politici), già riluceva della livida luce che illumina le macerie: era possibile arrestarsi su quella strada che avrebbe portato alle azioni, catastrofiche sul piano politico oltre che umano, dellʼassassinio di Alessandrini, di Emanuele Iurilli e di William Waccher?Lʼistantanea del funerale bolognese di Barbara “Carla” Azzaroni, cui parteciparono migliaia di compagni e compagne, può essere indicativa di uno stato di sospensione che sarebbe forse stato possibile: «Sarebbe bastato uno sguardo calmo alla situazione e a quel corteo funebre per rinunciare alla rappresaglia, per raffreddare la rabbia e cominciare un serio esame sul che fare. Ma era come se a ogni errore e a ogni smacco operativo crescesse il velo davanti agli occhi e la vista si appannasse sempre di più»7. Se con lʼassassinio di Emanuele Iurilli, vittima innocente di unʼazione di rappresaglia, «si rompe definitivamente il sottile filo di seta che ancora ci legava al movimento e alla realtà» (Bruno Laronga, p. 333), è perché quel rapporto con la realtà era già sottile come un filo.
Nelle ricostruzioni delle diverse manifestazioni del movimento antagonista degli anni ʼ70, compare sempre un momento nel quale si dovrebbe dire, e talvolta lo si dice,8 che «non cʼè più tempo». Che i possibili si sono esauriti, e in assenza del possibile la vita, il movimento, lʼessere, soffoca. È su questa sensazione di soffocamento che chiude questo primo volume: alle soglie di quegli anni Ottanta dai quali non nessuno è mai più uscito vivo. «Non basta avere ragione: bisogna che la ragione te la diano», ha detto qualcuno; un motto che si attaglia anche alla storia di Prima linea, ai suoi militanti caduti (ciascuno ha le proprie Spoon River, e ciascuna di esse merita rispetto), e ai molti che hanno ripreso, con nuove forme, le lotte interrotte dalla detenzione: in buona parte quelle lotte trasversali per lʼambiente, il riconoscimento, il diritto alla vita dei detenuti, dei tossicodipendenti, dei diversamente reclusi che le ragioni di Pl aveva intuito. Contraddizioni apparenti, che trovano in una storia che oggi sembra lontana (abbastanza da poter essere storicizzata) radici e percorsi carsici.
Note
- A fronte dei 911 condannati delle Br, vi sono 923 di Pl, a cui si aggiungono i 149 dei Comunisti organizzati per la liberazione proletaria (Colp) e le decine di militanti di altre sigle minori (cfr. Renato Curcio, La mappa perduta, Sensibili Alle Foglie 1994; Giorgio Galli, Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata dal 1970 a oggi, Baldini Castoldi Dalai 2004; Sergio Segio, Una vita in Prima linea, Rizzoli 2006). Sul periodo dei “boia delle carceri” si vedano la nuova edizione di Sergio Segio, Miccia corta. Una storia di Prima linea, Milieu 2017, pp. 206-219; e Toni Negri, Galera ed esilio, a cura di G. De Michele, Ponte alle Grazie 2017, pp. 41-43. Nella pagina facebook dedicata al libro si possono trovare molti documenti archivistici e altre fonti (primarie e secondarie) che la casa editrice del libro di Andrea Tanturli, DeriveApprodi, mette a disposizione dei lettori.
- Il riferimento è alla deposizione di Michele Viscardi durante il processo di Torino a Pl (nello specifico, sull’ipotesi di una “talpa” nella Procura di Torino che abbia fornito informazioni sul giudice Alessandrini: ipotesi che non ha trovato riscontri) (p. 302).
- Adriano Prosperi, “Terrorismo italiano. Le porte di entrata e di uscita”, in Passato e presente, n. 96, 2015, pp. 164; Prosperi sta recensendo Monica Galfré, La guerra è finita. LʼItalia e lʼuscita dal terrorismo 1980-1987.
- “Susanna Ronconi. Una vita da film”, in Rossella Simone, Donne oltre le armi, Derive e approdi, 2017, p. 98.
- Luca Rastello, Piove allʼinsù, Boringhieri 2006, p. 156.
- Esemplare ad es. la genesi di Senza Tregua allʼinterno della Magneti Marelli di Sesto San Giovanni (pp. 71-85), ricostruita sul ritmo delle lotte e del farsi dellʼautonomia allʼinterno del conflitto di fabbrica.
- Sergio Segio, Una vita in Prima linea, Rizzoli 2006, p. 168.
- Vedi il saggio introduttivo di De Lorenzis, Guizzardi, Mita a Avete pagato caro non avete pagato tutto. La rivista «Rosso» (1973-1979), Derive e Approdi 2008, p. 69.
Fonte: Girolamo De Michele, Il lavoro culturale