Impermeabile a qualsiasi cambiamento, era Bad ‘e carros, il carcere speciale di Nuoro. Il peggiore.
Vuotare il bacino d’acqua dove i terroristi nuotano, lo chiamavano. Fuor di metafora voleva dire inquisirne cento per prenderne uno. E tra quei cento, molti erano persone con scarse o nessuna responsabilità , che in certi casi finivano per trascorrere anni e anni di carcere duro. E ha voluto dire, almeno in un certo periodo, torture nelle celle delle caserme e delle questure, finte esecuzioni e pestaggi dopo l’arresto, comàè successo a molti. Me compreso. Ha voluto dire partorire in una branda, in una stanzetta davanti ai poliziotti con i mitra in mano, come accadde alla nostra compagna Sonia Benedetti.
Nella mia esperienza carceraria molto tempo ho trascorso nel carcere della città in cui abitavo, San Vittore a Milano. Da dove, complice la direzione del vento o qualche spiraglio visivo consentito dalle finestre dei piani alti, si può “annusare” la metropoli, ricordarne i ritmi, ritrovare, in questo caso piacevolmente, i rumori del traffico. In qualche modo, un supplizio di Tantalo, un tarlo metropolitano proustianamente piantato nella memoria del recluso, eppure preferibile alla nebbiosa asetticità delle prigioni più recenti, collocate in aperta campagna o nelle estreme periferie. Proprio come le discariche dei rifiuti: sono prodotti da tutti, ma nessuno li vuole vicino.
All’epoca del mio primo soggiorno, nel 1976, dal finestrone nel corridoio del terzo raggio, si poteva scorgere un angolo dei giardini di piazza Aquileia e, in quel modo, comunicare coi gesti dellà“alfabeto muto”, sia pure un poà ostacolati dalla pesante grata, con la fidanzata o gli amici all’esterno. Una comunicazione complicata e precaria, ma pur sempre una comunicazione. Un pezzetto di libertà sottratto alle forme sepolcrali della clausura legale. Dalle celle questo non era possibile, a causa della “bocca di lupo”, una specie di lastra tombale che chiudeva quasi interamente il vano della finestra, impedendo la vista e la circolazione dell’aria. Fattore che in estate non mancava di causare disagi. Ma, anche da lì, arrampicandosi sul davanzale, si poteva se non altro rubare uno spicchio di cielo o di stelle alla monotonia avvilente del ferro-cemento.
Altri tempi, decisamente. Allora, San Vittore somigliava un po’ alla galera turca immortalata dal film Fuga di mezzanotte: una vera e propria bolgia, in cui i detenuti, specie i mafiosetti, avevano una relativa libertà di movimento. Nei cortili giocavano a dadi, con grandi pacchi di banconote gettate a terra, sotto gli occhi delle guardie. In ogni cella c’era il “regolamentare” coltello a scatto, comprato, naturalmente, dal “cavallo”, cioè dalla guardia, così come ogni altro oggetto proibito, alcool soprattutto; la droga, allora, non era molto diffusa e richiesta. Il coltello entrava spesso in azione per regolare i debiti di gioco, gli “sgarri”, i conti delle bande esterne e le supremazie instabili di quelle interne. C’era un ordine parallelo, esercitato da una gerarchia parallela, decisamente tollerata e talora protetta da quella ufficiale, poiché, in certa misura, il fine e l’interesse erano comuni: l’ordine, appunto, cui piegare la massa dei detenuti e le “batterie” indipendenti. Necessario alla direzione per governare la bolgia, quando non bastavano i pestaggi e i trasferimenti punitivi alle isole (in particolare all’Asinara, governata da un despota, tal Cardullo, che si atteggiava a poeta ed effettivamente era monarca assoluto di quel carcere); agli altri, i mafiosi, per preservare ed estendere i traffici e gli affari.
Un equilibrio che, proprio in quegli anni, cominciò a incrinarsi e vacillare. Per due ragioni: la riforma introdotta nel 1975, che muoveva i primi passi, introducendo un minimo di diritti, e l’ingresso di carcerati particolari, quelli delle prime organizzazioni armate di sinistra, cui si univano i detenuti protagonisti del ciclo di lotte e rivolte che aveva portato alla riforma. Allora, detenuti politici e “politicizzati” eravamo pochi: una ventina, concentrati al primo raggio. Ma la novità era vissuta con fastidio e preoccupazione dai poteri interni: così, quell’anno, i coltelli si misero in azione, ferendo tre compagni, mentre facevano la doccia. Uno dei tre era l’avvocato Sergio Spazzali, attivo nel “Soccorso Rosso”; fu poi scarcerato, nuovamente inquisito e infine rifugiato in Francia, dov’è morto nel gennaio 1994.
Un secondo e assai più lungo soggiorno mi ha riportato a San Vittore nell’autunno del 1983 per il primo maxi-processo a Prima Linea, cui ne seguirono ininterrottamente diversi altri. Provenivo dal carcere di Torino, dove si era concluso un precedente processo e dove tornai nel 1987, al termine dei processi milanesi.
Da qualche anno, dentro l’isola di San Vittore ne era stata costruita una seconda, assai più impenetrabile e separata: la sezione speciale, ubicata nel primo raggio. Nella primavera à84, con l’inizio del processo alle BR-Walter Alasia, contemporaneo al nostro, lo speciale si estese anche a una parte del secondo raggio. Isola nell’isola, prigione nella prigione, in quel momento non aveva nulla da invidiare al più duro dei carceri speciali, quello di Nuoro. Tranne che respirare, tutto il resto era proibito. Fuori, il dinosauro della lotta armata vibrava gli ultimi colpi di coda. Dentro, l’onda lunga e incattivita dell’emergenza trattava i detenuti politici come ostaggi.
Ma, proprio allora e a partire da quel carcere, qualcosa cominciava a cambiare. Complici le udienze quotidiane del processo, pian piano, cominciammo a comunicare tra di noi e, soprattutto, con la città . La socialità nei gabbioni dell’aula-bunker dove si svolgeva il processo ci consentì di creare crepe progressive nel coperchio della morte civile e dell’isolamento.
La sezione speciale di San Vittore, così come quella di Torino, rimase comunque ancora per anni sottoposta all’articolo 90 dell’ordinamento penitenziario, in base a cui era vietato avere in cella più di due paia di calze o di mutande, scrivere ad altri detenuti, pur se parenti, fare i colloqui senza vetro divisorio antiproiettile, oppure muovere un solo passo fuori dalla cella, se non scortati da due agenti di custodia.
Il polo opposto, impermeabile a qualsiasi cambiamento, era Bad ‘e carros, il carcere speciale di Nuoro. Il peggiore. Era quello cui ministerialmente mi avevano assegnato, dopo la cattura, avvenuta in viale Monza a Milano il 15 gennaio 1983. Fortunatamente allora erano in corso i maxi-processi, che duravano anche anni e quindi per lunghi periodi comportavano la detenzione nelle sezioni speciali delle prigioni delle città in cui i processi si svolgevano, nel mio caso Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Padova. Arrivai dunque a Nuoro solo nell’estate 1983, nella pausa estiva del giudizio contro Prima Linea in corso a Torino.
I blindati dei carabinieri sui quali avevamo viaggiato, dopo la notte trascorsa in una cella del traghetto Genova-Olbia, vennero fatti fermare all’esterno, davanti al portone. Fummo fatti scendere. Eravamo a gruppi di 4 detenuti con gli “schiavettoni” ai polsi: sono dei pesanti attrezzi di ferro che tengono immobilizzate le mani. Gli schiavettoni vengono poi legati uno all’altro con una lunga e ancor più pesante catena e fissati da altrettanti lucchetti, così che si forma una fila di persone i cui movimenti sono pressoché impediti. Per questo motivo gli zaini contenenti i pochi effetti consentiti che ognuno di noi recava con sé venivano portati dai carabinieri di scorta. Le guardie a presidio del portone del carcere intervennero subito, dicendo ai militari che gli zaini, mediamente pesanti una ventina di chili, dovevano essere trasportati da noi stessi. E così fummo costretti a fare, in una penosa via crucis, ognuno barcollante sotto un paio di zaini, con le mani strattonate dai movimenti della catena collegata agli altri compagni di cordata. Era un’operazione assai difficoltosa, che comportava notevoli sofferenze, talvolta distorsioni e ferite ai polsi. Ma quello serviva a dare immediatamente il messaggio di cosàera il luogo e delle regole che vi vigevano.
La via crucis continuava con ore di attesa in una cella di transito in cui dovevano sostare i nuovi arrivati in attesa di essere immessi nella sezione. Lo stratagemma serviva ad alimentare timori e stress psicologico stante che, mentre durava l’attesa, nel corridoio sostavano drappelli di guardie schiamazzanti e ubriache che urlavano cose incomprensibili in sardo, lanciavano insulti e minacce in italiano, producevano rumori violenti.
Poi, uno per uno, si passava alla registrazione in matricola, con denudamento e non di rado pestaggio. Infine si veniva rivestiti da una sorta di divisa in ruvido panno marrone, i cui pantaloni e casacca venivano appositamente scelti dalle guardie di taglie difformi da quelle di ciascuno. A un magro venivano abiti enormi, così che i pantaloni cadenti, senza alcuna cinta o legaccio, rendessero difficile camminare. Ai più robusti di corporatura venivano date misure invece insufficienti, coi pantaloni a mezzo polpaccio e maniche che stringevano all’altezza dei gomiti. Così per le scarpe, di cuoio durissimo e private dei lacci, che venivano date di un paio di numeri inferiori oppure superiori a quello effettivo del proprio piede.
Anche qui, oltre al gusto cattivo con cui la gran parte di quegli agenti si esercitava in questo passatempo, il senso era quello di produrre un primo impatto forte di avvilimento e umiliazione. Una tecnica non dissimile da quella utilizzata nei lager e nei gulag, per come raccontata da Primo Levi e dai dissidenti russi. Quando si è privati di tutto, sinanche della possibilità di guardarsi allo specchio o della possibilità di parlare con i propri vicini di cella, comàè accaduto in certi braccetti speciali, spontaneo sorge l’interrogativo: “Se questo è un uomo”, se lo si è ancora e se si potrà mai tornare a esserlo.
Arrivando lì, mi resi immediatamente conto che la fama di Bad ‘e carros era del tutto meritata, quanto a durezze e sadismi. È l’unico carcere dove io abbia mai visto non solo le squadrette degli agenti ma lo stesso direttore venire in sezione con il manganello in mano. Per andare all’aria nelle gabbie esterne o alla doccia, quando era concesso, si doveva passare, uno per volta, in mezzo a due ali di guardie che agitavano minacciosamente il manganello, pronte a usarlo; il che accadeva di sovente.
Dopo poco tempo, e riuscendo a conservare uno sguardo ancora un po’ distaccato di uno che arrivava dall’esterno, l’impressione più forte che ricavai era che fossero tutti matti. Agenti e detenuti. Erano tutti da tempo avvitati in una contrapposizione estremamente violenta e al tempo stesso rituale. Una guerra di cui nessuno forse ricordava l’origine ma che assorbiva la totalità del tempo e delle energie di ciascuno.
Le posate naturalmente erano di plastica. Quando si rompevano i denti della forchettina, per farsela sostituire, occorreva riconsegnare non solo il manico ma tutti i singoli pezzettini di plastica. Anche il sacchettino di carta del pane era proibito. Qualsiasi cosa era interdetta. Naturalmente, nella logica dei carcerieri, importante non era il singolo oggetto in sé quanto la didattica del divieto, la spoliazione totale a rappresentare il potere illimitato sul prigioniero e sul suo corpo. E non a caso questo tradizionalmente era tanto più possibile su un’isola. Prima l’Asinara e Pianosa, poi, dopo le rivolte che spinsero allo loro chiusura, Nuoro furono i luoghi più feroci, veri e propri lager.
Dello speciale di Nuoro è rimasto paradigmatico l’episodio di un ago. Le guardie sapevano che era nascosto in una cella. Gli ospiti della cella sapevano che le guardie sapevano. La cella veniva perquisita, come tutte, più volte al giorno, senza che le guardie riuscissero a trovarlo. Dopo qualche tempo venne infine rinvenuto nel suo nascondiglio. Ma non sequestrato. Gli agenti lo lasciarono in bella vista sul tavolo. I detenuti lo occultarono di nuovo in un posto diverso, e tutto ricominciò. Era diventato una specie di maniacale giuoco di ruolo tra controllori e controllati. Un poà come la guerriglia all’esterno, ormai privata di meta e di senso.
Non c’era quasi giorno che a Nuoro non ci fossero zuffe e pestaggi. Di guardie e prigionieri ma poi anche tra detenuti con posizioni politiche o appartenenze organizzative differenti. Come per le cavie di laboratorio, quel trattamento atroce e scientificamente disumanizzante produceva follia e i reclusi cominciavano a sbranarsi a vicenda. O meglio, i brigatisti, in mancanza del nemico esterno cominciavano a inventarne uno interno. La logica stalinista e cannibalesca della caccia ai traditori stava diventando il nuovo rifugio maniacale delle brigate di campo, come si chiamavano le strutture brigatiste negli speciali. Ci provarono anche con noi. Un giorno organizzarono l’imboscata nella gabbia dell’aria per me, Maurice Bignami, Paolo Zambianchi e Sergio D’Elia. Eravamo di Prima Linea, organizzazione da loro considerata poco meno che controrivoluzionaria in quanto ritenuta portatrice di una linea sbagliata, soggettivista e movimentista. Non potevano accusarci di tradimento, perché anche la pratica della calunnia, della quale alcuni brigatisti erano decisamente professionisti, aveva dei limiti di credibilità . L’anno precedente avevo assaltato il carcere di Rovigo e, subito dopo, avevo cercato di organizzare l’assalto del carcere speciale di Fossombrone, dove contavamo di liberare parecchie decine di compagni, parecchi dei quali delle BR. E questo era da tutti risaputo. Due estati prima ero venuto a studiare le possibilità di far evadere dei compagni proprio dal carcere nuorese in cui ora mi trovavo. Insomma, era difficile farmi passare da traditore: ero uno dei pochi in quegli anni che dedicava le sue energie e rischiava la sua pelle e libertà nel tentativo di liberare i compagni dall’inferno delle carceri speciali. Quindi i brigatisti dovettero inventare una nuova categoria di nemici: quella degli “arresi”. In effetti, durante il processo di Torino, nell’estate 1983 PL aveva collettivamente prodotto un documento che giudicava la lotta armata non più proponibile e dichiarato il proprio scioglimento, un percorso autocritico che sfocerà poi in una più matura desistenza. Dalle armi, non dalla critica sociale e da una visione attivamente critica dell’esistente. In quel periodo, producemmo un secondo documento, pubblicato dal quotidiano “il manifesto”[1], che esemplificava il nostro cammino e intenzioni politiche, introducendo nel dibattito la categoria della “mediazione conflittuale”; un documento che, pur mancando la firma di altri esponenti dell’organizzazione esclusivamente in ragione della difficoltà di comunicare tempestivamente nel carcere speciale e tra maschile e femminile, rappresentava il punto di vista e il dibattito dell’intera PL e segnava una tappa evolutiva importante, come ben colse Rossana Rossanda: «Il documento che qui pubblichiamo porta le firme della dirigenza di Prima Linea, quella che è stata la formazione armata più forte assieme alle Brigate Rosse. Esso segna in modo netto – come scrive – il superamento dei e la separazione dai percorsi della lotta armata». Una riflessione importante e decisiva, scriveva Rossanda, che «va aiutata. A condizione di pensare le leggi d’uscita dall’emergenza col respiro di questo nuovo clima. Chi non lo intende e non si muove in esso, con fatica e serietà e responsabilità , resta ancora speculare a quella logica di annientamento che nelle carceri è stata battuta»[2].
Pur valorizzando il documento, nel suo corsivo l’editorialista e storica esponente de “il manifesto”, non coglieva però la sostanziale differenza e la maggior forza e credibilità di questo percorso rispetto alla precedente “dissociazione degli innocenti” dell’area del 7 aprile (e anzi attribuendo a questa una funzione maieutica, anziché di freno comàera obiettivamente stata), ma, soprattutto, accreditava – con generosità ma pure miopia – anche alle BR e alla gran parte delle detenzione politica la fine della logica di guerra e annientamento. Invece, lo scontro era drammaticamente aperto e in atto nelle carceri speciali, la logica dell’annientamento permaneva, favorita anche dal silenzio all’esterno.
Tutte le organizzazioni erano pressoché sgominate, quasi tutti i militanti erano in carcere, i “pentiti” dilagavano (importante, e purtroppo a tuttàoggi rara, la riflessione di Rossanda a riguardo di questi ultimi: «Gli adepti più fragili restarono nell’ottica della “guerra”, trasferendosi dall’altra parte, come pentiti attivi, collaboratori della polizia, come tali aiutarono a scoprire covi e dirigenze, portarono anche a operazioni inaccettabili come quelle di via Fracchia. Ma quel loro passare alla delazione avrebbe al contrario ricompattato le organizzazioni combattenti (…) se queste non fossero state ormai incrinate dalla crisi politica del loro progetto»[3].
Ma, per le BR, queste erano verità che non si volevano ancora vedere e che soprattutto non si potevano dire. Per loro i “pentiti” che collaboravano con la polizia e coloro che ponevano una riflessione politica sulla sconfitta e sul superamento delle armi, adoperandosi per una soluzione politica della prigionia, erano la stessa cosa (una lettura in cui venivano confortati da analoghi giudizi che venivano da qualche scampato a Parigi e dai soliti rivoluzionari dei salotti di casa nostra, tanto accesi verbalmente quanto inconseguenti, e ovviamente passati indenni da ogni inchiesta giudiziaria). E andavano trattati allo stesso modo.
Per questo a Nuoro volevano punirci e organizzarono l’agguato. Dal quale casualmente mi salvai, perché quel giorno non scesi all’aria (in successive occasioni in altre carceri, non fui così fortunato, pur se non riuscirono mai a farmi la pelle, come avrebbero probabilmente voluto). L’aggressione scattò comunque contro gli altri compagni ma con danni limitati, sia per la loro pronta reazione, sia per l’intervento delle guardie con gli idranti e i manganelli, che in questi casi aspettavano comunque sempre un poà prima di intervenire, per godersi lo spettacolo.
Coloro che erano rimasti in cella sentirono poco dopo il classico e purtroppo consueto frastuono del pestaggio: le urla, i colpi di manganello, le cariche delle guardie. Non ci si poteva rendere conto esattamente di ciò che succedeva, se non che era in corso un pestaggio. E quindi partimmo con una battitura delle sbarre, il solo modo di protestare di cui si disponesse. Solidarizzai così con i miei mancati aggressori. È solo uno dei tanti paradossi di quel luogo infame.
I brigatisti, furenti, il giorno dopo organizzarono un’inchiesta interna, supponendo che qualcuno di loro mi avesse messo sull’avviso. I sospetti si indirizzarono, verso un loro militante torinese, già operaio FIAT; evidentemente era già nella lista nera e gli infaticabili torquemada cercavano di accumulare pretesti per qualche nuovo processo ed esecuzione. La lotta armata era sconfitta, il sogno della rivoluzione decisamente in crisi, ma il “tribunale del popolo” brigatista a Nuoro e altrove non conosceva ancora pause e ripensamenti.
Noi, grazie anche al fatto di essere rimasti comunque gruppo solidale, avevamo le risorse per resistere e difenderci, pur se i burocrati del ministero e i magistrati che disponevano le assegnazioni alle varie carceri e sezioni facevano obiettivamente in modo di facilitare il lavoro ai boia delle carceri. Altri, più isolati, vennero distrutti dalla doppia e concorrente morsa di chi gestiva con ferocia le carceri speciali e delle, altrettanto e simmetricamente feroci, brigate di campo. Come Paolo Sivieri, militante delle BR, uscito da Nuoro e da quelle infami dinamiche profondamente spezzato. Quando era in cella, i brigatisti inossidabili gli gridavano dalle finestre: «Impiccati». Una volta gli fecero trovare in cella un cappio.
E con un cappio effettivamente si impiccò. A casa sua, poco dopo la scarcerazione, dopo essere stato tardivamente restituito a una libertà vuota e disumana, com’era stata la galera e una parte dei suoi compagni.
Anche questo furono le carceri di quell’epoca. Capitoli ignobili e misconosciuti di una storia della detenzione politica tutta ancora da scrivere.
[1] Chicco Galmozzi, Roberto Rosso, Sergio Segio, Nicola Solimano, Un documento di Prima Linea per la soluzione politica, “il manifesto”, 17 gennaio 1984.
[2] Rossana Rossanda, Dalla critica della lotta armata all’idea di conflitto e mediazione, ivi.
[3] Ibidem.




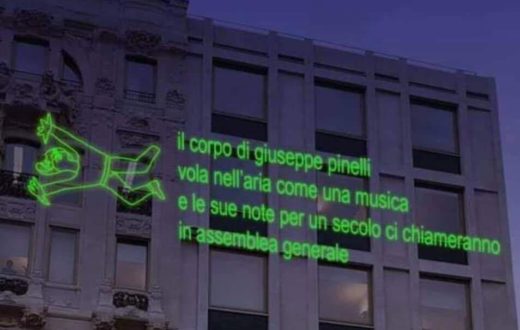
0 comments