«La mia cattiva strada. Memorie di un rapinatore», di Marcello Ghiringhelli edito da Milieu
Il terribile fulmine di vendetta raccontato nel prologo del libro di Marcello Ghiringhelli, La mia cattiva strada. Memorie di un rapinatore (Milieu, pp. 229, euro 15), ricorda quello che attraversa la frase di Carlo Emilio Gadda (Lettere agli amici milanesi): «la sconcia bestia è stata appesa in Piazzale Loreto». Due fatti dello stesso momento storico: il linciaggio di una collaborazionista e l’esposizione del corpo del capo. L’analogia tra i due scrittori si ferma qui. Ghiringhelli scrive i suoi libri raccontando la sua nuda vita vissuta, Gadda si vendicò con le parole contro un dittatore e contro la sua «rinnegata» adesione al primo fascismo.
LA FRENETICA e telegrafica scrittura di Ghiringhelli è agli antipodi del lavoro sulla lingua del «gran lombardo». Costruzione di una sintassi innovativa, lavoro sul lessico con invenzioni neologistiche e sprofondamenti etimologici non riguardano Ghiringhelli, e a noi in fondo non interessa se l’efficace struttura del libro è opera dei curatori o dello scrittore, qui è la vita che parla. La mia cattiva strada racconta l’esistenza dell’autore dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ’70, «va letto con mente aperta, come testimonianza tremendamente vera e sincera», sostengono i curatori Davide Ferrario e Marilena Moretti.
Ragazzo proletario della periferia torinese intrisa di sentimenti antifascisti, tra ribellione, fame, cure in manicomio con l’elettroshock, e poi la fuga in Francia, legionario a 17 anni durante la guerra algerina, «carnefice e carne da cannone», fa in tempo a «vergognarsi» e a fuggire ancora, entrando nella mala, con scorribande tra Milano e Parigi. Poi ancora imprenditore a Torino, dove si accorge che la «cattiva strada» è più onesta dell’accumulo del plusvalore e la ripercorre per qualche decennio, tra rapine e amori. È un libro mozzafiato dove l’avventura e le scelte esistenziali lasciano spazio a una visione politica, a un’analisi di classe, che lo porteranno, a inizio degli anni ’80, quando il libro si chiude come a preannunciare un seguito, alla militanza nelle Brigate Rosse.
«È un libro all’insegna del banditismo, con storie d’affare e malaffare, quelle storie che non si leggono sui giornali», dichiara l’autore. Prima che gli archivi di polizia vengano rispolverati e le vite degli «uomini infami» siano rilette dagli storici, un senza-storia racconta la propria storia. L’attenzione al particolare della microstoria permette di accedere a verità altrimenti inattingibili e di scoprire aspetti del passato che rischiano di andare perduti.
QUESTA MICROSTORIA scuote «più fibre di quante ne solleciti quella che normalmente chiamiamo letteratura», come scriveva Foucault a proposito dei documenti analizzati in La vita degli uomini infami. Anche nella scrittura di Ghiringhelli «è tale la stringatezza delle cose dette, che non si sa se l’intensità che le attraversa dipenda maggiormente dal risplendere delle parole o dalla violenza dei fatti» che in esso si agitano.
Leggendo questo memoir denso di termini gergali dell’argot e di vari idiomi, viene da chiedersi se nel meritevole catalogo della Milieu non possa trovar posto la traduzione di Les princes du jargon di Alice Becker-Ho, un testo fonmdamentale, come sostiene Giorgio Agamben, per rimettere in discussione «la catena esistenza del linguaggio-grammatica (lingua)-popolo-Stato».
* Fonte: IL MANIFESTO


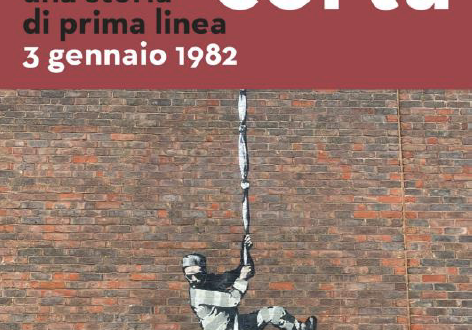




0 comments