Internet non è solo una semplice tecnologia del controllo, ma anche il laboratorio dove ha preso forma e si sviluppa il nuovo capitalismo neoliberale
Internet. Un’intervista con il teorico della Rete Evgeny Morozov, in Italia per partecipare a un seminario a Settimo Torinese. Internet non è solo una semplice tecnologia del controllo, ma anche il laboratorio dove ha preso forma e si sviluppa il nuovo capitalismo neoliberale
Il percorso teorico di Evgeny Morozov è eccentrico rispetto il mainstream intellettuale su Internet.
Cresciuto in Bielorussia ha partecipato al movimento d’opinione che chiedeva una cesura del paese con il suo passato sovietico. In quella congiuntura ha frequentato corsi di giornalismo on line, diventando in pochi mesi un mediattivista che vedeva nella Rete un potente strumento per veicolare istanze di libertà e di innovazione sociale. È con questa convinzione che è sbarcato negli Stati Uniti, diventando in breve tempo un blogger noto per la sua capacità di mettere a fuoco i punti forti e le possibile contaminazioni della network culture con il mondo dei media tradizionali.
Anni di lavoro giornalistico e teorico, che lo portano a guardare con scetticismo la rete come «incarnazione» di un regno della libertà.
La pubblicazione del volume Le ingenuità della Rete (Codice edizioni) è un condensato di questa presa di distanza dal «cyber-utopismo», dove Internet più che regno della libertà è descritta come una tecnologia di controllo.
La polemica di Morozov, divenuta nel frattempo docente universitario, è contro chi continua a chiudere gli occhi sul potere esercitato dalle imprese dell’high-tech, sull’uso della Rete da parte dei governi nazionali per controllare le comunicazioni dei cittadini, ridotti a sudditi di un potere che non tollera forme di dissenso e alterità rispetto il pensiero dominante.
Descritto come un teorico conservatore, privilegia invece un «liberalismo radicale» come background per criticare i monopolisti della Rete e della decisione politica.
Ma le sorprese che lo studioso bielorusso non finiscono con la pubblicazione di due pamphlet. Uno è dedicato alla mitizzazione di Steve Jobs come campione di innovazione (Contro Steve Jobs, Codice edizioni) e Internet non salverà il mondo (Mondadori), j’accuse contro i tecnocrati del web.
Morozov radicalizza infatti la sua posizione e comincia ad usare un lessico militante, nel quale sono forti gli echi della critica marxiana al capitalismo. In una intervista alla «New Left Review» e in un articolo scritto per «Le Monde Diplomatique», arriva a proporre, provocatoriamente, l’espropriazione dei Big Data e la necessità di una rinnovata teorica critica del capitalismo neoliberale.
Morozov sarà ospite oggi a Torino di due seminari.
Il primo è alla scuola Holden (ore 11), il secondo è previsto invece per oggi pomeriggio a Settimo Torinese come anteprima del «Festival dell’innovazione e della scienza» che inizierà il 19 ottobre. L’incontro di oggi pomeriggio, invece, organizzato da Codice edizioni e dal Nexa Center for Internet & Society — Politecnico di Torino, vedrà Morozov dialogare con Luca de Biase (giornalista delSole 24 ore) e il giurista Carlo Blengino.
In un recente saggio ha scritto che occorre odiare Silicon Valley. Perché dobbiamo odiare la «valle del Silicio»?
La ragione principale per odiare la Silicon Valley è semplice: i ragazzotti che vi lavorano si sentono degli intoccabili e le imprese che hanno la loro sede lì si ammantano di non so quale manto di umanitarismo nobile. In realtà sono le imprese più rapaci che si possono incontrare. Molto più di molte che operano a Wall Street. Ho maturato questo punto di vista negli ultimi tre anni. Ho però constatato che è molto difficile trovare uomini e donne che si pongano dubbi e domande sull’operato delle imprese tecnologiche della Silicon Valley. Questa difficoltà è dovuta al fatto che quelle stesse imprese riescono a imporre alla discussione pubblica una rappresentazione del loro operato indiscutibile: chi fa domande o esprime dubbi sul loro operato è dipinto come un oscurantista. I miei scritti, ad esempio, sono stati liquidati come l’espressione di un tecnofobo che vive nelle foreste perché odia la modernità. A nessuno, però, verrebbe in mente di squalificare in questo modo le mie posizioni se, ad esempio, criticassi Wall Street o le compagnie petrolifere.
Alcuni anni fa, Eric Schmidt, uno del triumvirato a capo di Google, ha detto, con fare profetico, che la Silicon Valley e società come Google rappresentano l’essenza del capitalismo contemporaneo contro il quale è vana ogni forma di protesta e opposizione. È venuto però il tempo di affrontare seriamente, e con onestà intellettuale, la posizione di Eric Schmidt.
La Silicon Valley è un un fenomeno sociale, economico e politico emerso in una particolare congiuntura nella storia del neoliberalismo, quella che vede dispiegarsi processi di privatizzazione e deregulation.
È solo partendo da questo primario elemento che possiamo comprendere e aiutare a far comprendere che Google, Facebook e le tantissime startup formate e spesso fallite nella Silicon Valley non sono composte da persone disinteressate, altruiste, benevole. Sono ragazzotti che hanno lavorato intensamente per cambiare i rapporti di potere nella società, rendendoci più dipendenti, ostaggio delle imprese di quanto accadesse in passato. L’esito del loro operato è una completa e radicale finanziarizzazione di ogni aspetto della vita quotidiana. Questo è il sottile e tuttavia più pericoloso fattore che emerge con lo sviluppo della Silicon Valley.
Penso che questa sia la strada obbligata per sviluppare una critica puntuale del ruolo svolto dalla tecnologia nel ridisegno dei rapporti di potere, a favore delle imprese, va da sé, nella società.
Lo slogan iniziale di Google era «don’t be a devil», non essere il diavolo. Per molti, invece la società di Mountain View è proprio un diavolo perché si appropria dei nostri dati personali per fare affari. Per altri, invece, questa espropriazione è il prezzo da pagare per usare gratuitamente un buon motore di ricerca che facilita la nostra vita in Rete. Quale è il suo punto di vista?
Parto da una constatazione. In poco più di un decennio si sono formate delle imprese globali che hanno conquistato posizioni di potere, economico e non solo, su scala globale. Google è una di queste imprese globali. Per i singoli, l’elemento importante è che possono usare il suo software e i servizi gratuitamente, senza soffermarsi sul fatto che condividi con una società privata molti dati personali sensibili. Il suo modello di business è molto astuto e all’apparenza «innocente», ma non lascia molti margini di manovra .
Nessuno in Europa, a differenza di quanto invece è accaduto in Russia, Cina e alcuni paesi dell’America latina, ha mai lavorato seriamente per sviluppare società e modelli di business che riducessero la dipendenza dal potere di Silicon Valley nel plasmare le nostre vite. Questo non è dovuto a un approccio ingenuo verso la tecnologia, quanto a una certa ingenuità europea verso l’«impero americano».
Solo così si spiega, ad esempio, il consenso di molti paesi europei al Ttip: consenso che rimuove qualsiasi analisi sulle implicazioni geopolitiche, «imperiali» e tecnologiche del trattato.
La Rete è anche una tecnologia del controllo. È usata dagli stati nazionali per spiare e controllare i cittadini. È altresì usata dalle imprese per raccogliere, elaborare e «impacchettare» informazioni sensibili per essere vendute. Potremmo dire che gli stati nazionali e le imprese hanno dato vita a un complesso militare-digitale, che si affianca a quello militare-industriale. Costituisce, anch’esso, un pericolo per la democrazia?
Parto dalla convinzione che la National Security Agency e l’intelligence militare statunitense sono molto contenti, se non felici del ruolo svolto dalle società tecnologiche. Il potere occulto che abbiamo chiamato complesso militare-industriale non è scomparso e quello che vediamo in azione è una sua evoluzione.
Non è certo produttivo fare profezie sul futuro, ma alcune ipotesi sui rapporti tra imprese e intelligence sono utili per capire come si sta strutturando uno «stato di sicurezza nazionale» che ha come architrave processi di privatizzazione e di concentrazione monopolista.
Faccio un esempio: c’è un paese dove la comunicazione avviene attraverso una infrastruttura di proprietà pubblica, che garantisce affidabilità, riservatezza, anonimato. L’intelligence di quel paese ha già il materiale con il quale lavorare, visto che l’accesso ai dati è previsto se viene invocata la sicurezza nazionale. Può accadere che quella infrastruttura venga poi privatizzata e acquisita da una impresa. I dati personali sono così nelle mani dell’intelligence e delle imprese private. È quello che è accaduto in molte parti del pianeta.
La privacy è un diritto universale, dicono giuristi e attivisti. Ma la privacy è anche un business crescente nella Rete. I ricchi, viene sostenuto, possono acquistare servizi e software che garantisce la loro privacy, i poveri no. Cosa nel pensa?
La logica del capitalismo neoliberale è trasformare ogni cosa in merce. E questo vale anche per la privacy.
Finora il discorso sul diritto alla riservatezza era relegato al campo giuridico o alle norme che regolano le relazioni tra gli Stati. Le rivelazioni di Edward Snowden hanno fatto molto scalpore, ma non hanno avuto grandi effetti, né aggiunto molto a ciò che era noto.
La logica del capitalismo neoliberale è trasformare ogni cosa in merce. E questo vale anche per la privacy.
Ciò è dovuto al fatto che Snowden non ha mai dimostrato una disponibilità a criticare il capitalismo o la politica di potenza degli Stati Uniti. Elemento, quest’ultimo, presente anche in Julian Assange. In ogni caso l’affaire Snowdenè sempre stato affrontato su un piano prevalentemente giuridico. Non è mai emerso nella discussione pubblica nessun accenno alla struttura monopolistica del capitalismo, né è stato messo a fuoco il processo di privatizzazione in atto.
Snowden d’altronde non è molto interessato di chi è la proprietà e come opera l’infrastruttura della comunicazione. Essendo un libertario, potrebbe anche manifestare sentimenti positivi verso il fatto che le imprese della comunicazione siano private invece che statali.
D’altronde, i libertari americani sono indifferenti al tema delle forme di proprietà. Sono portati a rappresentare i governi nazionali come asteroidi distinti e separati da quelli delle imprese private. Nulla dicono dei monopoli, delle relazioni tra lo stato e il mercato.
Non sono dunque sorpreso che il tema della sorveglianza, della privacy non contempli mai la mercificazione della vita o la privatizzazione dei beni pubblici. Eppure a Berlino ci sono decine e decine di start up, alcune delle quali senza fini di lucro, che stanno sviluppando app di qualità per la tutela della privacy in Rete.
Non sono così ingenuo da credere che il capitalismo neoliberale sarà sconfitto da una applicazione per la Rete, così come non credo che le politiche di austerità possano essere contrastate sviluppando una app.
Ritengo più realistico immaginare lo sviluppo di movimenti sociali con una autonoma proposta politica e analisi economica sulle dinamiche che hanno portato a questo tipo di capitalismo. È così infatti che si possono individuare delle soluzioni e un superamento di questo stato di cose, compresa anche la difesa della privacy.
In recenti interventi e interviste lei ha affermato che i Big data dovrebbero essere socializzati. Ci sono echi di politiche socialiste di nazionalizzazione in questa posizione. Vuol dire che lo spettro del comunismo si può aggirare nuovamente nel mondo?
Non sono interessato a discutere se il comunismo è morto o se sta risorgendo.
Pongo solo il problema di come restituire le informazioni personali che sono andate a costituire i Big Data. Ho posto il problema cioè della loro proprietà e della mercificazione dei dati personali.
Occorre cioè immaginare modelli di gestione alternativi al dogma dominante neoliberale. Questo sia a livello nazionale, ma anche sovranazionale. È la partita attorno ai Big Data che occorre giocare. E si deve andare in campo con la giusta preparazione e un’adeguata strategia.











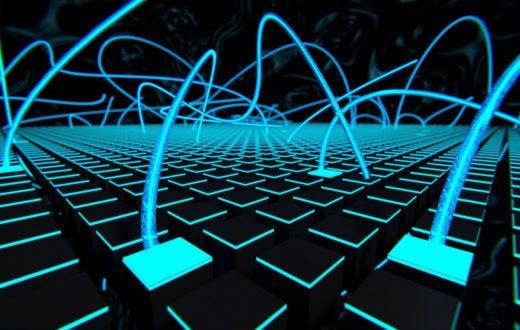


0 comments