Il libro. Il processo del 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore Giovanni Palombarini
Un secolo prima di quel 7 aprile 1979 il giurista liberale Francesco Carrara scriveva che in materia politica le regole del diritto criminale si trasformano sempre in una poesia arcadica. Ipse dixit. Quasi cento anni dopo il Pubblico Ministero Pietro Calogero nella sua requisitoria finale del 23 gennaio 1978, definì Autonomia Operaia come un movimento reazionario costituito da emarginati della classe borghese la cui ideologia non era altro che «un nuovo fascismo». Un giudizio quantomai singolare per un magistrato, che rivelava un malcelato livore tendente ad escludere dal novero della sinistra i movimenti antagonisti comparsi ormai da anni nello scenario politico padovano e nazionale. Un giudizio non giuridico ma politico che coincideva esattamente con quello del PCI. Gli esponenti più in vista del partito parlavano di «nuovo squadrismo» e di «diciannovismo» e furono parte attiva nella costruzione di quella operazione politico-giudiziaria che criminalizzò il movimento dell’Autonomia Operaia associandolo alle BR, costringendo al carcere preventivo per molti anni decine di persone risultate alla fine innocenti. Ma non c’era solo il PCI a sostenere la tesi del PM, tranne pochissime eccezioni infatti vi era anche buona parte della stampa che dieci anni prima aveva già sperimentato, col processo Valpreda per la strage di piazza Fontana, il ruolo colpevolista di appoggio alla tesi dell’accusa diventandone spesso portavoce e megafono. Improvvisamente i giornalisti dell’Unità, di Paese Sera e dell’Avanti sino allora emarginati dagli uffici giudiziari e polizieschi ottenevano notizie inedite, primizie, confidenze. In coro riportavano le tesi inquisitorie ampliandole e sottolineando al contempo le «presunte debolezze ed incertezze dei giudici istruttori». Nessun dubbio sul «partito calogeriano dell’insurrezione» come invece non mancavano di sottolineare i media internazionali. In questo clima niente affatto tranquillo, dunque, si trovò ad operare Giovanni Palombarini che, a 36 anni di distanza, è tornato a scrivere di quel processo nel volume Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore Giovanni Palombarini, Il Poligrafo editore. Il magistrato, già presidente di Magistratura Democratica, confronta tra loro atti giudiziari, ricostruzioni giornalistiche e lucidi ricordi personali in un imprevedibile intreccio che tra le righe rivela anche fatti sorprendenti rimasti sinora sconosciuti. Uno colpisce tra i tanti. Un giorno Palombarini riceve dal PM un fascicolo zeppo di documenti. Al suo interno trova una busta inviata a Calogero dal Procuratore Generale di Catanzaro nella quale, con una breve lettera di accompagnamento, era contenuto un rapporto del Sisde sullo stesso Palombarini. Evidente il tentativo di delegittimare il giudice istruttore accusato dagli ambienti del PCI padovano di essere vicino al mondo dell’Autonomia.
Le divergenze tra Pietro Calogero ed i giudici istruttori Giovanni Palombarini e Mario Fabiani sono note. Il primo riteneva che lo scioglimento di Potere Operaio nel 1972 non ci fosse mai stato e che Autonomia Operaia Organizzata operasse per l’insurrezione attraverso il partito armato. I secondi sostenevano invece che non esistevano risultanze processuali che dimostrassero un legame associativo fra Autonomia e Br. Ritenevano inoltre che ci fosse una profonda differenza fra la linea strategica e l’iniziativa concreta espressa dai primi e quelle dell’organizzazione clandestina. Il giudice istruttore nel suo libro ricostruisce meticolosamente le diverse ed intricate fasi dell’inchiesta che iniziò due anni prima quando nel marzo del 1977 Calogero spiccò mandati di cattura contro giovani aderenti ai Collettivi Politici Veneti accusati di azioni come le occupazioni delle mense universitarie, le interruzioni delle lezioni universitarie, aggressioni a docenti e così via. L’accusa di associazione per delinquere viene mossa anche ad alcuni docenti e tecnici della facoltà di Scienze Politiche tra cui Antonio Negri. Curiosità: Palombarini ricorda che proprio nel novembre di quell’anno a Padova si tenne un convegno sul tema «Operaismo e centralità operaia» organizzato dall’Istituto Gramsci Veneto a cui parteciparono Giorgio Napolitano, Massimo Cacciari, Alberto Asor Rosa, Mario Tronti e Aris Accornero. Nell’aprile del ’78 il giudice istruttore Palombarini dichiarò non provata l’esistenza di una organizzazione centrale veneta dell’Autonomia Operaia e quel primo processo si concluse col rinvio a giudizio di qualche imputato per reati specifici, mentre cadde per strada l’associazione per delinquere. Ma anziché chiudere la partita il PM nel ’79 ritorna ad accusare di sovversione gli stessi imputati ipotizzando che a Padova si celasse il vertice del terrorismo italiano che legava tra loro Autonomia Operaia e Brigate Rosse. In un delirio colpevolista militanti del PCI ritennero di riconoscere le voci di Toni Negri e del giornalista dell’Espresso Giuseppe Nicotri come quelle dei telefonisti delle BR durante il sequestro Moro. Così alle 10 di quel famoso 7 aprile 1979 un aereo atterra al «Marco Polo» di Tessera, una cinquantina di ufficiali della Digos arrivano a Padova su due pullman e mezz’ora dopo assediano la città con mezzi blindati. L’operazione fu mastodontica: 22 ordini di cattura, 70 ordini di comparizione e un centinaio di perquisizioni domiciliari. Tra gli arrestati Antonio Negri, ordinario di Dottrina dello Stato all’Università di Padova; Luciano Ferrari Bravo, assistente; Emilio Vesce, direttore di Radio Sherwood e della rivista Autonomia; Oreste Scalzone, fondatore dei Comitati comunisti rivoluzionari; Mario Dalmaviva, leader torinese di Potere operaio. Il 16 aprile da Roma, ritenuta territorialmente competente, arriva un altro mandato di cattura contro Antonio Negri, accusato di essere (insieme a Moretti, Alunni, Micaletto, Peci, Faranda, Morucci e altri 16) l’assassino di Moro e dei cinque uomini della sua scorta. A Padova rimangono gli imputati «minori», quelli per cui non scatta il coinvolgimento nell’insurrezione armata.
Dopo cinque anni, il 12 giugno 1984, viene emessa la sentenza di primo grado del troncone padovano. E mentre nel ’79 il procuratore della Repubblica di Padova Aldo Fais aveva assicurato la stampa dicendo che se non avessero avuto prove sicure «mai e poi mai saremmo usciti con così gravi provvedimenti», cinque anni dopo tredici imputati vengono assolti per insufficienza di prove, uno con formula piena; 34 sono giudicati colpevoli di reati associativi; 21 di reati specifici. Il processo si chiuderà due anni dopo con l’assoluzione di quasi tutti. Anche la sentenza di secondo grado della Corte d’assise d’appello romana nel 1987 riduce vistosamente le pene e propone nuove assoluzioni. Sentenza confermata l’anno dopo in Cassazione. Tutti gli imputati vengono assolti del reato di Insurrezione armata. Ma mentre a Roma è la stessa Procura della Repubblica a chiedere il proscioglimento con formula piena di Negri del reato di associazione sovversiva e banda armata, a Padova le cose vanno diversamente. Tra Procura e giudice istruttore volano scintille. Già nel ’79 Calogero chiedeva che nel collegio istruttore non ci fosse Giovanni Palombarini che accusava di aver incontrato Negri almeno quattro o cinque volte. In realtà si era trattato di incontri legati ad udienze. Il giudice piduista Antonio Buono parla di colleganze ideologiche e la stampa vicina al PCI accentua la sua ostilità nei confronti del giudice. Palombarini sottolinea la mancanza o l’insufficienza di prove specifiche relative ai vari capi di accusa. Definisce le prove testimoniali molto spesso generiche e caratterizzate da valutazioni, impressioni e riferimenti a cose dette da terze persone quasi mai indicate nominativamente. Gli vengono sottratti persino i collaboratori di giustizia. Nel dicembre del ’79 Carlo Fioroni ex militante di Potere Operaio, ad esempio, depose a Roma, Milano e Padova, ma i giudici istruttori Palombarini e Fabiani non furono avvertiti del pentimento e l’interrogatorio del collaboratore si svolse a loro insaputa. Questo ultimo inoltre quando Palombarini si recò a Roma per sentirlo si rifiutò, in qualità di imputato, di rispondere. Fu grazie alle sue dichiarazioni che Antonio Negri fu accusato del sequestro e dell’omicidio di Carlo Saronio oltreché dell’omicidio del magistrato milanese Emilio Alessandrini. Continue nuove imputazioni che costeranno agli imputati una ulteriore estensione fino ad altri quattro anni della carcerazione preventiva. Ad indignarsi però c’è solo Amnesty International che interviene nell’agosto del 1983 con un durissimo comunicato. Calogero non arretra nemmeno dopo l’interrogatorio del brigatista Patrizio Peci che negherà ogni legame con Autonomia Operaia e tantomeno con Toni Negri.
I contrasti col giudice istruttore si protrarranno fino alla fine, causando così una lunga sequenza di provvedimenti giudiziari contrastanti tra loro, un balletto di impugnazioni e di scarcerazioni degli imputati, alcuni dei quali non potranno che scegliere di fuggire in Francia. Ma a supportare le perplessità dei giudici istruttori ci sono anche i giudici. Basti pensare che nella stessa severa sentenza del 26 luglio 1980 dopo un processo per direttissima il Tribunale scriveva che si metteva sotto accusa non tanto la dinamica dei fatti ma «soprattutto la sua genesi politica». Quella sentenza venne accolta dagli imputati presenti in aula con il canto dell’Internazionale e dopo pochi mesi Palombarini riconoscerà la libertà provvisoria a dodici dei ventisette imputati condannati a meno di due anni di reclusione revocando anche i provvedimenti restrittivi nei confronti dei latitanti Roberto Ragno e Pietro Maria Greco. Questo ultimo dopo due anni ritornò latitante per un altro mandato di cattura spiccato dalla procura veneziana e venne ucciso dalla polizia nel 1985 a Trieste mentre, disarmato, tentava di fuggire. I poliziotti responsabili vennero assolti nel 1986, in quella occasione il poeta Franco Fortini scrisse una lettera al Ministro della Giustizia Mino Martinazzoli che venne poi pubblicata dal settimanale L’Espresso. Stefano Rodotà commenterà dalle pagine del Manifesto le scarcerazioni per mancanza di indizi e la sentenza di proscioglimento con formula piena del 4 settembre 1981 di Del Re, Bianchini e Serafini parlando di assoluta inconsistenza delle prove. Nel suo libro Palombarini non si sottrae dal fare alcune interviste a Severino Galante, Gianni Riccamboni, Giorgio Tosi e Giovanni Valentini testimoni del tempo ed esponenti della società civile percorsa da laceranti fratture ieri come oggi. Ma ciò che più preme al giudice è come un approccio deduttivo quale quello del PM che partiva da «verità precostituite» abbia posto il problema di «drammatica rilevanza» della carcerazione preventiva. Nell’ultima pagina del libro Palombarini scrive infatti «nel succedersi di innumerevoli provvedimenti di carcerazione e scarcerazione — in qualche caso di imputati che ad un certo punto si sono rifugiati all’estero ma che comunque hanno inizialmente sofferto di periodi non trascurabili di custodia cautelare, e in altri casi di persone trattenute costantemente in carcere con imputazioni clamorose — è avvenuto che alla fine, dopo anni, accuse gravissime si siano dissolte in numerose sentenze di assoluzione. È possibile su questo oggi sviluppare una riflessione?». Un nodo ancora irrisolto che riguarda non solo il processo penale ma soprattutto i fondamenti della nostra civiltà giuridica e la stessa tenuta della democrazia.


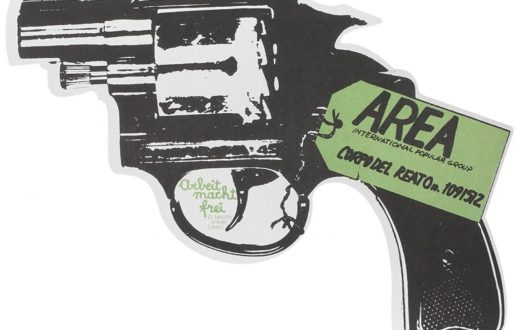
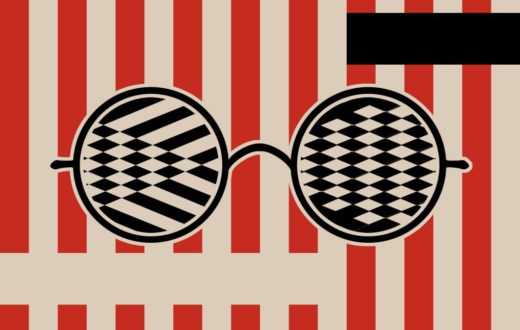




0 comments