Generalmente si vede e si immagina il carcere come una realtà immobile: le sbarre sono sempre le stesse. In realtà , dal Dopoguerra a oggi il carcere è antropologicamente cambiato più volte.
Generalmente si vede e si immagina il carcere come una realtà immobile: le sbarre sono sempre le stesse. In realtà , dal Dopoguerra a oggi il carcere è antropologicamente cambiato più volte.
Nell’immediato Dopoguerra, a San Vittore c’erano oltre 3000 detenuti. La rivolta del 1946 (la “Pasqua Rossa”) venne stroncata con i carri armati: ma, anche all’interno, c’erano detenuti decisamente armati. Uno strano cocktail, tipico dei periodi di transizione dopo un conflitto aspro e sanguinoso: banditi molto determinati (la banda Bezzi-Barbieri, ad esempio), partigiani che intendevano continuare la lotta contro i fascisti, saloini ancora in cerca della bella morte.
L’amnistia Togliatti portò la normalizzazione, anche se qualcuno pagò un prezzo molto caro: l’ultimo esponente della Volante Rossa sarebbe uscito solo negli anni Settanta.
Fino alla fine degli anni Sessanta le galere hanno conosciuto un pendolarismo di piccola malavita, qualche mafioso a denominazione di origine controllata, alcuni, pochi, banditi di “classe”, come i rapinatori di via Osoppo a Milano. Il regolamento interno continuava a essere quello emanato da Alfredo Rocco insieme al codice penale, coniugandosi bene con il perbenismo che pervadeva la società civile: dai giornali venivano tagliate le foto di donne in bikini, chiamate con un bel linguaggio burocratico “nudo balneare”. Nelle celle, per i bisogni fisiologici, ci stava il bugliolo.
Alla fine degli anni Sessanta si verifica il primo mutamento significativo. In carcere arrivano i ragazzi delle “batterie”, giovani rapinatori con un forte senso di appartenenza. Il gruppo, per loro, è tutto. Un po’ come nel “Mucchio selvaggio”. Sono, per alcuni aspetti, integrati: amano la bella vita degli anni dello sviluppo economico; e, allo stesso tempo, sono ribelli: insofferenti a qualunque ordine e gerarchia. In carcere, rovesciano i rapporti di forza instaurati fino a quel momento. La vita interna, prima di allora, era governata da un tacito accordo tra secondini e mafia.
I primi imponevano l’ordine, la seconda la sudditanza.
Un esempio interessante del cambio di paradigma è quanto avviene al quinto raggio di San Vittore, tradizionalmente considerato il raggio dei detenuti di rispetto: l’arrivo di questi giovani ribelli fece saltare equilibri radicati da decenni, con gli atteggiamenti dissacranti nei confronti dei mafiosi e la conflittualità permanente con la custodia. Anche personaggi che fino a quel momento erano stati in bilico tra malavita metropolitana e organizzazioni criminali, come Francis Turatello, finirono per accettare il nuovo corso.
Poi furono le rivolte, i tetti e la distruzione di interi bracci nelle fatiscenti carceri delle grandi città. Azioni pagate a caro prezzo, con decine d’anni di galera supplementare. Nacquero in quel periodo, erano i primi anni Settanta, i primi gruppi di detenuti fortemente orientati in senso rivoluzionario. Rilevante fu l’esperienza dei Nuclei Armati Proletari, formati da detenuti in carcere e da ex detenuti, oltre a militanti politici, all’esterno: una storia intensa e drammatica, di fragole e sangue.
Lo Stato reagì con la repressione ma anche con la riforma dell’ordinamento penitenziario: nel 1975 venne approvata la legge n. 354 che ridefiniva mondo e regole delle prigioni. In senso più democratico e aperto, con l’introduzione delle prime forme di pene alternative. Ma spirito riformista ed etica della rivolta non sono mai andati troppo d’accordo. I detenuti avevano cominciato a prendere gusto ad assaporare la libertà evadendo, anche armati. E sempre più numerosi.
Si affermò allora una nuova spirale repressiva, culminata con l’apertura di nove carceri di massima sicurezza nel 1977: Cuneo, Novara, l’Asinara, Nuoro, Fossombrone, Pianosa, Trani, Favignana, Termini Imerese, oltre al carcere femminile di Messina. In seguito, Palmi e Ascoli Piceno avrebbero sostituito Termini Imerese e Favignana. A dirigere quell’operazione venne chiamato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I luoghi vennero scelti in base alla loro inaccessibilità o alla struttura fortificata: in alcuni casi anche in base all’organizzazione agguerrita degli agenti di custodia che vi agivano. Dalla Chiesa chiamò quel pugno di carceri “circuito dei camosci”, a dire di un percorso aspro e difficile. Venne accolta in quelle prigioni l’aristocrazia ribelle del crimine: politica e comune.
Da lì non evase più nessuno, mentre le condizioni interne divennero sempre più pesanti. Fino all’applicazione integrale dell’articolo 90: colloqui con il vetro divisorio, nessun pacco viveri, posta censurata, libri smembrati in fascicoli, nessuna forma di socialità interna, un’ora d’aria al giorno, in sei per volta, con i cavalli di frisia ai lati.
Ma, fuori, arrivò anche la sconfitta della lotta armata; e, dentro, l’irruzione del pentitismo. Ne derivò un imbarbarimento collettivo, con la caccia all’“infame”, che finì per vedere il nemico semplicemente in chi, senza aver detto alcunché, aveva un pensiero divergente.
Furono anni cupi e bui, quelli tra il 1981 e il 1984.
Nel 1986, dal primitivo intento di regolamentare l’applicazione dell’articolo 90 dell’Ordinamento Penitenziario, uscì la legge Gozzini, che, pur tra scelte discutibili e titubanze, apriva le porte del carcere alle misure alternative.
La guerra, quella guerra, era finita.
Negli anni Novanta il carcere ha iniziato una nuova mutazione antropologica. Da una parte i sepolti vivi del 41 bis, la riedizione aggiornata dell’articolo 90, per gli affiliati di peso, veri e presunti, alla criminalità organizzata; poi un gruppo consistente sottoposto all’alta sorveglianza per reati come l’associazione a delinquere, l’associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di persona. Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati e sovraffollati in celle senza nulla, se non la disperazione. Sono perlopiù tossici che cercavano droga e stranieri che cercavano cibo o rifugio, ma che hanno trovato davanti a sé solo sbarre. In quindici anni, la popolazione carceraria è raddoppiata e le carceri sono diventate il luogo, in senso letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la fanno a sopravvivere.
Sono le scorie della globalizzazione.
Zygmunt Bauman, nelle ultime pagine di “Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone”, traccia le linee del legame forte che unisce l’irrompere della globalizzazione con il grande aumento della popolazione carceraria: negli stati Uniti, dal 1975 a oggi, i detenuti sono aumentati del 700%; in Francia, il direttore dei servizi penitenziari di Parigi, nel corso di un’audizione alla Commissione di inchiesta sulle condizioni negli istituti di pena dell’Assemblea Nazionale, ha detto che le prigioni sono tornate a essere gli ospedali generali di un tempo: l’auberge des pauvres, il ricovero di ogni categoria di emarginati.
Una sintesi efficace della situazione in molti Paesi d’Occidente.
Le diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione sono accompagnate da squilibri sociali sempre più forti, che incidono sulle fasce deboli della popolazione, nei movimenti migratori dal Sud del mondo e all’interno degli Stati dell’Occidente. La povertà disseminata è la vera altra faccia della medaglia della globalizzazione.
Negli Stati Uniti nel 1973 c’erano stati 96 detenuti ogni 100.000 abitanti, nel 2005 sono saliti a 726: in numeri assoluti si era passati da 204.000 a oltre due milioni di reclusi. Tra il 1983 e il 1995 il numero dei detenuti è passato da 43.000 a 55.000 nel Regno Unito, da 39.000 a 53.000 in Francia, da 14.000 a 40.000 in Spagna. La popolazione carceraria in quindici anni è triplicata in Olanda ed è aumentata anche in Paesi tradizionalmente fautori di politiche di decarcerizzazione come quelli scandinavi. In Italia, sempre in 15 anni, dal 1991 al 2006, la popolazione carceraria è passata da trentamila a oltre sessantunmila detenuti, nonostante una capienza massima di 46.000 posti. Di più: alla vigilia dell’indulto quasi 50.000 persone rientravano nella dimensione dell’area penale esterna, vale a dire nel circuito delle misure alternative, a fronte delle 12.000 presenti dieci anni prima. Le pene al di fuori delle mura del carcere avevano poco di alternativo, come invece erano state immaginate, e molto di complementare. Semplicemente, la strategia del controllo si era ampliata dall’interno all’esterno, andando a costituire una continuità di fatto tra sistema penitenziario e sistema assistenziale, tra carceri e centri di accoglienza (De Vito, 2009). Non a caso, la legge Fini-Giovanardi del 2006 chiede alle comunità una funzione di controllo ancor prima che terapeutica. Immigrati e tossicodipendenti sono diventati i due terzi della popolazione carceraria complessiva: da qui il termine di discarica sociale attribuito al carcere. In questo periodo si è passati dallo stato sociale allo stato penale. Complessivamente, l’area penale nel 1990 coinvolgeva 36.300 persone, nel 2005 si è arrivati a 190.000 persone (Maisto, 2011).
In carcere oggi ci stanno soprattutto i poveri: sono gli occupanti abusivi del carcere (Castellano, Stasio, 2009). Circa un detenuto su quattro, quando termina la pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e traumatici della società lasciano sul terreno delle vittime incolpevoli, i poveri, e delle vittime colpevoli, i disperati che compiono reati per fame di cibo o di droga.
Dell’indulto, nel 2006 hanno potuto usufruire 24.500 detenuti, tra cui oltre 15.000 italiani e oltre 9.000 stranieri, e 17.500 persone in misura alternativa. Sono usciti in molti casi solo con i sacchi neri e spesso senza sapere dove andare. Nessuna rete di protezione e di inserimento è stata approntata per loro, come invece previsto dalla proposta avanzata nel 2000 dagli ex detenuti Sergio Segio e Sergio Cusani, chiamata “20” per le carceri, che aveva ottenuto l’adesione di migliaia di associazioni, di cooperative sociali, di imprese. I detenuti, scesi a meno di 40.000 con l’indulto, sono tornati a 49.000 unità alla fine del 2007 e a oltre 56.000 alla fine del 2008, nonostante sia rientrato un numero modesto di persone che avevano ottenuto lo sconto di pena. Al 31 ottobre 2011 i detenuti ammontano a 67.428 unità, seimila in più rispetto al momento dell’indulto.
La povertà continua a essere incarcerata.
In prigione i poveri cristi entrano con grande facilità ed escono con grande fatica. Giustizia e povertà non si sono mai amate: oggi i poveri non sono in grado di far valere i loro diritti, anche quando le leggi parlano teoricamente a loro favore. Nei loro confronti vincono la disattenzione, l’indifferenza, il cinismo. Sarebbe ora di cambiare rotta, verso l’attenzione, l’accoglienza, l’inclusione nella sfera dei diritti essenziali e delle relazioni sociali.
Cecco Bellosi, Relazione introduttiva al 5° master in medicina delle emarginazioni, delle migrazioni e delle povertà, 18 novembre 2011
*************************
Citazioni bibliografiche
Bauman Zygmunt (1999), Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Editori Laterza, Roma-Bari
Bevilacqua Alberto (2003), La Pasqua Rossa, Einaudi, Torino
Castellano Lucia, Stasio Donatella (2009), Diritti e castighi, il Saggiatore, Milano
De Vito G. Christian (2009), Camosci e girachiavi, Editori Laterza, Roma-Bari
Maisto Francesco, Il corpo e lo spazio della pena, a cura di Anastasia Stefano, Corleone Franco, Zevi Luca, Ediesse, Roma





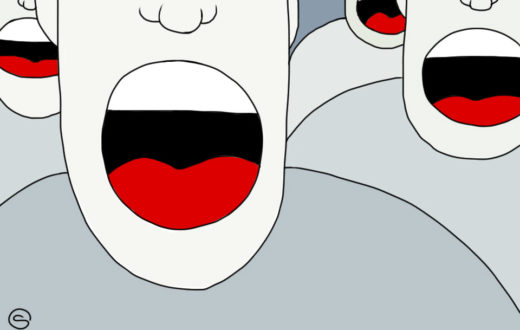

0 comments