ma che non è detto non sia ancora qui, annidato nel tempo presente, pronto a balzar fuori
Le Nuove di Torino, tra gli anni ’70 e gli ’80
Il sotterraneo me lo ricordo, c’ero scesa con Liviana e con suor Angela. C’erano vecchi bauli da svuotare, abiti da scena per recite di detenute dei decenni precedenti, prima della riforma. Abiti donati da signore della Torino bene, paillette, seta, frange. Abiti indossati da chissà quali donne: chi c’era prima di noi e prima delle tossiche e prima delle rapinatrici, libere donne degli anni settanta?
C’erano le donne semilibere, qui, fino a qualche anno fa, dice suor Angela. Che angoscia, sussurro io. Bello schifo, alla faccia della riforma, dice Liviana.
Le celle sono sotto il livello del terreno, una grata piccola e oscurata da polvere, terra e ragnatele fa intravedere il ciglio del cortile di cemento. Un ottocentesco soffitto a volte percorre il lungo corridoio dove si affacciano porte di legno grigio con chiavistelli spropositatamente grandi, e spioncini piccoli. Ovunque buio e umido. Un filo di luce a mezzogiorno, e scalpiccio di pantegane, specie d’estate. Del sotterraneo, me ne aveva parlato Sara, del suo letto di contenzione alle celle delle Nuove, nell’anno della rivolta, il ’77. Del sorriso del maresciallo, dopo la lotta e le urla e il rifiuto di entrare in cella, nel girare le bende ruvide attorno ai polsi e fissarle al pancaccio. Due giorni e due notti. Lame di sole obliquo e buio e topi e mosche. E le voci delle altre, a chiamare a salutare e fischiare per non farla sentire sola. E le urla delle guardie a farle tacere.
Mani legate e corpi esposti al potere totale di un altro e buio intorno pieno di rumori da decifrare senza poter dormire e scalpiccio di topi o di anfibi militari che si avvicinano (perché vengono qui? per fare cosa? cosa accadrà , adesso?)
Santa Verdiana – Firenze – Isolamento – 1982
Voci di donne, ora, stemperano la tensione accumulata in caserma tra rumore di passi, porte aperte di scatto, uomini a cerchio sempre attorno, lo sguardo fisso sul mio viso. Il carcere mi accoglie di nuovo nel suo grembo di matrigna, mi nutre di cibo in scodelle di acciaio, mi prepara il letto con lenzuola ruvide, di quelle che durano una vita (…). Il suono femminile tenace delle voci, giù in cortile, e la femminile perversità di accudire un corpo chiuso, mi danno una sorda tranquillità .
Le voci delle compagne, in cortile, si fanno più eccitate, rimbalzano sui muri alti del vecchio convento, passano le prime sbarre, e la rete fitta, e le seconde sbarre della piccola finestra. Le riconosco, ad ognuna il suo volto. Alcune mi emozionano. Il mio nome e poi “fuori dall’isolamento”, urlato, scandito, cantato. Sensazione calda, sono accudita, ora posso anche piangere un po’. Quasi mi assopisco, vedo la luce trascolorare verso un riflesso dorato, non ho l’orologio, intuisco un pomeriggio d’autunno che si consuma, là fuori. Le donne, nel cortile, non scandiscono più il mio nome né gli slogan per avermi con loro. Percepisco una contrattazione, le loro voci, acute e sovrapposte, si alternano ad una voce, singolare e maschile. Le strisce di sole sul muro, ormai rosate, mi dicono che il pomeriggio volge alla fine. Dovrebbero essere chiuse in cella già da ore. Si rifiutano di rientrare, contrattano ancora. Ho paura di sentire anfibi militari avanzare rabbiosi sul cemento del cortile, mi sento impotente. Mi sento desiderata, anche: impotente e intenerita.
Voghera – Massima Sicurezza – 1983
Le divise informi di stoffa ruvida con stampigliato sulla schiena “Trani – 1944” (ma eravamo belle lo stesso, bastardi, Dio se eravamo belle). E quando mettevano brutta musica a tutto volume sparata dagli altoparlanti in tutti i corridoi per impedirci di comunicare tra noi, noi cantavamo più forte, fino a gonfiare le vene del collo. E quando, al momento dell’arrivo, ci mettevano nude in fila e ci facevano fare sei flessioni e poi ci cacciavano a forza sotto le docce calde, per vedere se la vagina, rilassata dal calore, lasciava cadere esplosivi, messaggi cifrati, documenti politici, lettere d’amore clandestine, cacciavamo le lacrime in gola e cercavamo i nostri sguardi più sprezzanti e, perfino, qualche scintillio di ironia. E quando, rivestite delle divise naziste, e calze color militare che scendevano al polpaccio ad ogni passo e scarpe di cartone, incalzate dal fiato sul collo dello sbirro che dava il ritmo dell’apertura dell’infinita teoria dei cancelli blindati ripetendo “muoviti puttana”. Sì, anche allora eravamo belle, bastardi, Dio se eravamo belle.
Giudecca – Venezia – Isolamento 1988
Il carcere della Giudecca, con il grande portone, mi ingoia insieme alla scorta. Dovrò odiare questo luogo, anche questo luogo: me ne dispiace, è la mia città . Non è così che avrei voluto tornare, non in catene. Non si può stare chiusi, a odiare un luogo che si ama, per cui si muore di nostalgia. Ogni carcere è migliore di questo: il più buio, il più umido, il più duro. Ma qui, resistere alla struggente luce della sera, e alle campane in lontananza, e al dialetto dolce parlato dai carcerieri, e alla voce dei gabbiani. Qui la prigionia è insostenibile.
Voci e suoni domestici, la lingua cantilenante, la lingua di mia madre. A sentire sardo e napoletano, almeno, potevo proteggermi con una estraneità ; qui, invece, sono avviluppata dalla perversione della familiarità . Tutto qui mi rende inquieta: pochi cancelli, molte suore, la guardia della matricola con le pantofole friulane di velluto e gli occhi chiari, nessuno grida, pavimenti di legno antico. Eppure, i corpi sono chiusi, qui come altrove. È un penale, il carcere del tempo definitivo. Provo, per tutta questa dolcezza, un fremito di ribrezzo e, allo stesso tempo, di fascinazione. Il carcere tutto militare e maschile e duro da cui vengo mi tranquillizza e al contempo mi spaventa, visto da qui. Cosa e chi sto diventando, se addirittura lo rimpiango? Perché sono più salda sulle gambe lì che qui? Le donne qui mangiano insieme, non nelle loro celle, ma in una sala comune. C’è aria di refettorio, di convitto. Ma io ho una cella per me, non posso parlare con nessuna. Sono contenta di stare da sola. Voglio ripensare a tutto il luccicore del mare, allo Stucky che mi ha accolta. Voglio morire di nostalgia, piangere, finalmente non vista.
Posso farlo: la cella è molto grande, potrebbe ospitare sei donne, anche di più, con i letti a castello. C’è un angolo, vicino al cesso, che rimane nascosto allo spioncino, fallimento della paranoia del panopticon. Se mi metto lì, posso piangere e pensare non vista. Da quanto non ho il dono dell’invisibilità ? Si può fare, qui: sedia e tavolo e letto non sono imbullonati al pavimento, tutto si muove e si sposta, come in una stanza vera. La finestra ha sbarre e rete, lascia intravedere poco del mondo. Però, schiacciando il viso sulle sbarre, a destra, lo sguardo – forzando gli occhi fino a far male – arriva ad una cupola chiara, a uno scorcio di tetti, e proprio vicino a me, è appollaiata una coppia di colombi. Sono stanca. Prendo la sedia che mi rende invisibile e apro il mio libro.



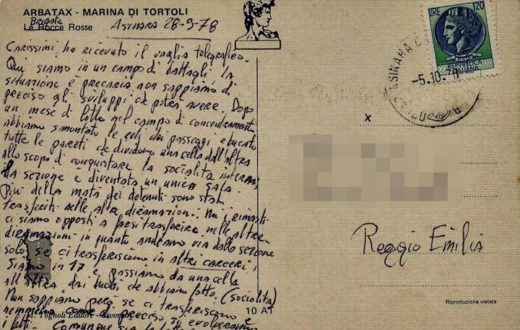
0 comments